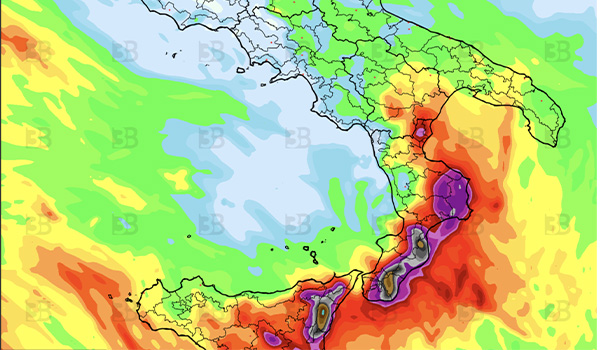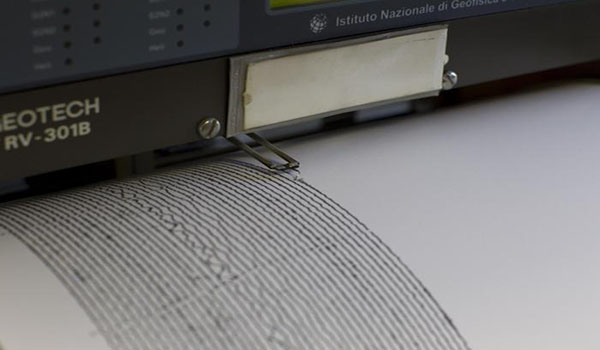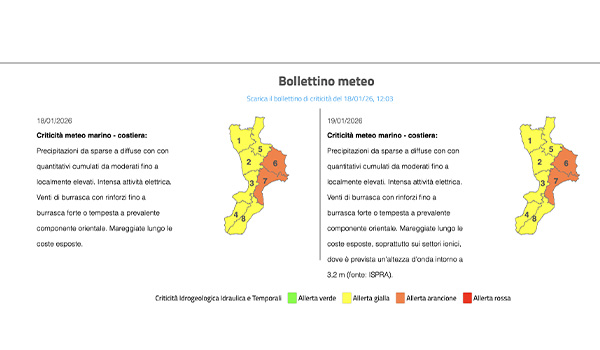Con Paolo Borsellino allo Zen di Palermo. Intervista a Mariangela Di Gangi


PALERMO, 19 LUGLIO 2013 - Ci sono città senza luoghi e ci sono storie prive di un’esatta e chiara cronologia. Esistono città, come Palermo, dove vi sono delle zone di differenza, ovvero delle terre di con-fine rappresentate da quei cosiddetti quartieri di periferia da tenere a debita distanza.[MORE]
Qui gli edifici non determinano soltanto degli spazi geografici ma definiscono dannatamente anche gli spazi sociali. Qui più che ad una sana socializzazione ogni individuo sembra essere destinato all’isolamento e al degrado o ancor peggio ad una vita suddita del malaffare. È il caso dello Zen di Palermo, nome dall’accezione orientale e quindi infingardo dato che è il semplice acronimo di Zona Espansione Nord, un agglomerato urbano costruito negli anni ’70 col nobile proposito di essere un luogo di aggregazione e sviluppo ma che in realtà ha prodotto una “città nella città”, un luogo di messa al bando, di emarginazione, dove alle incurie e alle inadempienze delle istituzioni nella gestione dei servizi sopperisce sciaguratamente la mafia.
Sì, perché allo Zen di Palermo se una famiglia indigente vuole riconosciuto il proprio diritto alla casa non deve rivolgersi all’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ma al boss che gestisce l’insula (così si chiamano i palazzi di questo quartiere di periferia ispirati per tipologia dall’architettura romana), perché soltanto lui decide a chi vendere l’abitazione garantendo perfino luce e acqua. Già, la mafia, l’organizzazione criminale che ha contrassegnato e contrassegna mortalmente non soltanto la storia e la cultura della Sicilia, bensì dell’intero Paese. E non può che essere così, perché le stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992 coinvolgono indistintamente tutti i cittadini italiani.
Esse hanno, difatti, aperto una stagione amara e vigliacca dove uomini dello Stato sarebbero scesi indegnamente a patti con i boss di Cosa Nostra. Una storia dalla quale non ci si può sottrarre poiché densa di pagine oscure e irrisolte che si legano drammaticamente con le morti di uomini irreprensibili, come i giudici Falcone e Borsellino. Uomini per i quali, in una dimensione così torbida, non ci poteva essere spazio: troppo ingombranti e scomode le loro rivendicazioni di libertà ed onestà. Dunque, ancora oggi, a distanza di 21 anni, per ogni singolo cittadino italiano vi è non soltanto l’instancabile obbligo morale di ricercare e desiderare la verità su quanto è accaduto ma vi è parimenti l’obbligo di impegnarsi nella lotta alla mafia, perché, proprio come indicava lucidamente Paolo Borsellino, «ognuno deve fare la sua parte: ognuno nel suo piccolo, ognuno per quello che può, ognuno per quello che sa».
Ci sono, allora, verità da riportare alla luce e ci sono spazi urbani da riscattare e ai quali ridare dignità ed identità. Una vera e propria missione che oggi, 19 luglio 2013, 21esimo anniversario della strage di via D’Amelio, percorriamo tra speranze e certezze attraverso un doppio binario: seguendo, da un lato, le parole di Paolo Borsellino e, dall’altro, domandandoci come e in che misura i suoi più che preziosi insegnamenti abbiano trovato reale concretezza nella coscienza civile dei cittadini e soprattutto dei giovani. Con questo ambizioso proposito ci siamo rivolti a Mariangela Di Gangi, giovane 28enne che da poco più di un anno è presidente dell’associazione “Laboratorio Zen Insieme”, un’associazione nata nel 1988, e che per tale ragione potremmo definire antesignana, e che opera, come suggerisce lo stesso nome, nel quartiere dello Zen di Palermo.
«Palermo è una città che a poco a poco, negli anni, ha finito per perdere pressoché totalmente la propria identità, nel senso che gli abitanti di questa città, o la maggior parte di essi, hanno finito per non riconoscersi più come appartenenti a una comunità che ha esigenze e valori uguali per tutti» . Per chi, come lei, agisce in un quartiere di confinamento e di disagio sociale come lo Zen, che significato assume, oggi, questa amara quanto attuale analisi di Paolo Borsellino?
E' chiaro che, in una realtà come quella dello ZEN 2 di Palermo, affermazioni come queste assumono una valenza molto particolare. Per buona parte del resto della città ha senso parlare di 'perdita di identità' e, quindi, del senso di Comunità. Ma per una quartiere come lo Zen 2 occorre fare riferimento ad altre ragioni. In quello che possiamo definire, senza esagerazione alcuna, un vero e proprio ghetto, è normale non sentirsi parte della Comunità, proprio perché al di fuori della comunità si è tenuti. Scientificamente. La scarsa presenza delle istituzioni, in tutte le loro forme, siano esse servizi sociali adeguati o i banali collegamenti col centro, è una motivazione sufficiente per far pensare a chi vive in quel posto che non si fa parte della Comunità. E come dicevo, tutto ciò è stato fatto scientificamente, per creare una zona franca nella città. Quello che bisogna chiedersi, soprattutto in prossimità di anniversari come quello del diciannove luglio, è a chi ha fatto e fa comodo tutto ciò, chi ha voluto e ha ottenuto scientificamente che allo Zen 2 di Palermo si creasse una Comunità nella Comunità. Perché di certo non sono stati gli abitanti del quartiere, ritenendosi figli di un Dio minore, a decidere di rinunciare a far parte della Città, di Palermo.
«[…] a Palermo è stata diffusa sino a ieri - non sino all'altro ieri, se non forse in alcuni ambienti sino ad oggi - l'impressione che le organizzazioni mafiose, potessero creare addirittura una possibilità di sbocco, di crescita economica perché creavano e portavano una ricchezza che lo Stato non riusciva ad assicurare». Lo Zen credo sia un esempio lampante di una simile situazione. Ci può spiegare, per quanto possibile, come la mafia agisce tra gli abitanti del quartiere per legittimare il suo potere ed ottenere il necessario consenso?
Esattamente nel modo opposto a come le istituzioni agiscono per ottenere lo stesso risultato. Con la presenza, con le risposte, con le regole certe. E' di pochi mesi fa un'indagine che ha messo in luce un sistema perfetto con cui la criminalità, allo ZEN 2 di Palermo, gestiva, a suo modo, tutto ciò che le istituzioni, di ogni grado, non sono state capaci di gestire. Negli anni nessuno ha lavorato seriamente per regolarizzare la piaga delle occupazioni abusive degli alloggi popolari o per assicurare che anche in quel quartiere fosse il comune di Palermo a erogare i servizi idrici. Lo ha fatto qualcun altro, che più prontamente si è attrezzato per gestire in maniera criminale e vessatoria, ma efficiente, quei sevizi che l'istituzione pubblica non erogava direttamente. Mi chiedo: sono gli abitanti del quartiere ad essere 'mafiosi' o ci sono delle colpe nel non aver permesso che vi fosse un'alternativa legale per esercitare dei diritti elementari, quali il diritto alla casa o all'acqua pubblica? E questo è solo uno degli esempi che possiamo fare. Frequento quel quartiere quotidianamente ormai da più di un anno e posso assicurare a ciascuno che non esistono particolari condizioni di fertilità per le mafie, se non la distanza delle istituzioni.
«[…] quella forma di consenso che ha reso la mafia pressoché, non voglio dire indistruttibile, ma l’ha resa così potente in Sicilia. Tanto potente che talvolta sembrano o appaiono inutili tutte le forme di repressione, anche quelle più dure, e probabilmente inutili sono se nei confronti della mafia ci si continua a limitare ad attività meramente repressive e giudiziarie e si continua a delegare a magistrati e polizia la lotta contro la mafia senza riflettere che bisogna togliere attorno alla mafia l'acqua in cui questo immondo pesce nuota. E l'acqua la si toglie da un lato insegnando ai giovani a diventare cittadini, a sapersi riconoscere nelle istituzioni pubbliche». Voi del “Laboratorio Zen Insieme”, attraverso le vostre attività, che si discostano fortemente da ogni forma repressiva, siete spesso costretti a compensare l’assenza e la noncuranza nel quartiere delle istituzioni. Eppure, paradossalmente, avete il compito di insegnare ai bambini ad avere fiducia nelle stesse. Come è possibile conciliare tutto ciò, attraverso quali parole e comportamenti? E poi, quanto pesa alla vostra stessa associazione tale assenza?
Io non distinguerei le nostre difficoltà da quelle dei nostri bambini o degli abitanti del quartiere, quando ci scontriamo con la noncuranza, definiamola così, delle istituzioni. Nel senso che le nostre piccole battaglie sono le loro stesse piccole battaglie. E le conduciamo assieme. Quando lottiamo per riavere il nostro piccolo centro sociale, non lo facciamo per noi, per la nostra associazione. Lo facciamo per il quartiere stesso, che ha il diritto di avere un luogo di ritrovo per i propri bambini che non sia la scuola o lo parrocchia. E gli abitanti sanno che quel luogo serve soprattutto a loro, che è loro. Le mamme sanno che serve per togliere i bambini dalla strada o per tenere impegnate esse stesse nelle attività che promuoviamo. I padri ci aggiustano le porte sfasciate dalle devastazioni che abbiamo subìto. I miei coetanei difendono quel luogo e non fanno altro che chiedere che venga riaperto, perché li sono cresciuti. La nostre battaglie sono le loro battaglie, dicevo. A noi spetta solo il compito, qualora serva, di guidarli verso la strada più giusta, quella della rivendicazione dei propri diritti attenendosi alle regole dello stato democratico in cui non abbiamo smesso di credere.
«Soltanto che questo è solo metà del cammino perché quand'anche tutti i giovani imparassero veramente a diventare cittadini e a rifiutare queste forme di organizzazioni che si pongono in alternativa, sotto questo profilo, allo stato sarebbe stato fatto metà del cammino. Perché l'altra metà del cammino debbono farla le istituzioni. Altrimenti questo incontro a metà strada fra i giovani che crescono e le istituzioni che rispondono a questa crescita culturale dei giovani non può avvenire. […] Ecco perché se da un lato si deve parlare ai giovani di mafia, soprattutto per insegnar loro a diventare cittadini, dall'altro meritorie sono quelle iniziative, e anche a Palermo ve ne sono, dove bisogna insegnare ai politici a fare politica. Che significa soprattutto agire nell'interesse di tutti e non nell'interesse né dei singoli né delle fazioni». Spesso gli abitanti dello Zen hanno denunciato come la presenza dei politici locali, tra le strade del quartiere, avvenga soltanto nei periodi elettorali per poi ricadere nella totale diserzione, incuranti dei problemi a cui avevano prestato falsamente tanto ascolto. Perché, secondo lei, i cosiddetti “politici di professione” sono tanto distanti da quella parte di polis che invece necessita e richiede un forte e deciso impegno?
I quartieri popolari sono quelli in cui è più facile far leva sui bisogni o tenere sotto ricatto la cittadinanza, questo è ovvio. Sono anche i quartieri in cui è più complesso occuparsi realmente dei problemi della gente. E' più semplice aggiustare una panchina in via Libertà e non avviare i lavori per la prima piazza del quartiere, come occorrerebbe fare allo Zen 2. E' più facile occuparsi di cultura nel centro della città e non provare a trovare soluzioni alla crisi occupazionale che colpisce i ceti poveri e i quartieri popolari più di altri. Una volta ottenuto il consenso elettorale, è più semplice fuggire dalle proprie responsabilità.
Nel suo ultimo discorso pubblico del 25 giugno 1992, il famoso intervento nell’atrio della Biblioteca Comunale di Casa Professa a Palermo, peraltro intitolato proprio lo scorso 25 giugno alla memoria del giudice, Paolo Borsellino esordì dicendo: «sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare, perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato». Tale intenzione era evidentemente resa necessaria dal ruolo istituzionale da lui ricoperto in momento delicatissimo come quello immediatamente successivo alla morte di Giovanni Falcone. Tuttavia quanto è importante nel vostro quotidiano agire allo Zen la capacità di ascoltare i suo abitanti?
Moltissimo. Rischieremmo, altrimenti, di essere noi per primi vittime dei pregiudizi. Se non avessi trascorso l'ultimo anno a parlare dei problemi dello Zen con chi allo Zen ci vive, le mie considerazioni oggi sarebbero molto diverse.
«Gli enti, le associazioni ed i comitati che si sono dati come finalità nobilissima quella della lotta alla criminalità mafiosa hanno il gravoso e meritorio compito di tenere ora come non mai desta l’attenzione dell’opinione pubblica sugli accennati problemi, affinché dietro il paravento della cosiddetta “normalizzazione” non si pervenga invece ad una frettolosa “smobilitazione” dell’apparato antimafia […]». Pensare la mafia come un male sconfitto ed abbassare la guardia sarebbe oggi, come allora, un errore imperdonabile. “Laboratorio Zen Insieme” da anni fa parte di quelle associazioni impegnate nelle attività della giornata di commemorazione della strage di Via D’Amelio, una delle più oscure pagine delle storia contemporanea italiana dove interessi di Stato e mafia si sono vilmente incontrati dando vita a quella che è stata ribattezzata “Trattativa”. Quest’ultima si arricchisce di continuo di nuovi elementi giudiziari ed investigativi ma senza mai giungere a conclusioni definitive né tanto meno chiare. Nella consapevolezza di agire in un quadro da troppo tempo irrisolto e nebuloso, non vi è talvolta il rischio di cadere nello sconforto e nell’idea che non si arriverà mai al raggiungimento della verità? E se sì, dove trovare comunque la ferma volontà di proseguire nella sua ricerca?
Non si può smettere di pretendere la verità. Non possiamo permettercelo noi, non può permetterselo la nostra democrazia, non può permetterselo il nostro Paese. Riuscire a capire non tanto cosa e come sia successo nel '92, ma soprattutto il perché, non serve soltanto a certificare un passato, ma soprattutto a capire su cosa poggia il nostro presente.
«Invece i ragazzi di oggi (per questo citavo i miei figli) sono perfettamente coscienti del gravissimo problema col quale noi conviviamo. E questa è la ragione per la quale, allorché mi si domanda qual è il mio atteggiamento, se cioè ci sono motivi di speranza nei confronti del futuro, io mi dichiaro sempre ottimista. E mi dichiaro ottimista nonostante gli esiti giudiziari tutto sommato non soddisfacenti del grosso lavoro che si è fatto». Secondo lei, in quale misura i giovani d’oggi sono realmente coscienti di vivere in una società, specie in una città come Palermo, dove l’ombra della mafia è presente in maniera capillare?
Le tragedie del '92 hanno cambiato la società in cui viviamo e, soprattutto, le coscienze di coloro che in quel momento erano solo bambini, come me. Siamo cresciuti con l'immagine forte di come la mafia ha colpito il nostro paese, le nostre istituzioni. Al contempo siamo cresciuti con l'esempio positivo, e altrettanto forte, di chi aveva accettato persino di rinunciare alla propria vita pur di compiere il proprio dovere. Credo che le consapevolezze di cosa sia la mafia e del suo essere un disvalore facciano parte del nostro bagaglio culturale. Credo anche che ormai, purtroppo, non abbia senso parlare di Palermo come città in cui le mafie sono particolarmente radicate, perché i fatti di cronaca di ogni giorno ci ricordano come le mafie si siano fatte strada ovunque. Penso anche, però, che noi, generazione dell'antimafia, corriamo due grandi rischi, adesso. Il primo è quello che, a furia di mitizzare e definire 'eroi' coloro che hanno, con uno straordinario senso dello stato e del dovere, portato avanti ad ogni costo il loro lavoro, ci si costruisca una sorta di alibi secondo cui noi, che siamo 'persone normali', siamo un po' sollevati dalla responsabilità di essere dei buoni cittadini sempre e dal seguire quell'impegno nello stesso modo. Spesso si tende a delegare l'antimafia a chi la fa per professione, urlando slogan d'effetto e commentando sui social media la cronaca giudiziaria meticolosamente, perdendo di vista il nostro personale impegno quotidiano. Il secondo rischio è quello di non distinguere più i buoni dai cattivi. Combattiamo tutti la mafia, almeno a parole, tutti abbiamo il diritto di commemorare, tutti abbiamo il diritto di essere definiti antimafiosi, fatte salve le condanne. E invece no. Io credo che occorra essere molto attenti proprio li, nel distinguere i buoni dai cattivi, a prescindere dalle vicende giudiziarie. Forse adesso i 'professionisti dell'antimafia' esistono davvero e a noi, che abbiamo avuto la fortuna di interiorizzare cosa sia davvero l'antimafia, spetta il compito di tracciare dei distinguo molto netti.
(Immagine www.sicilia24h.it)
Giovanni Maria Elia
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.