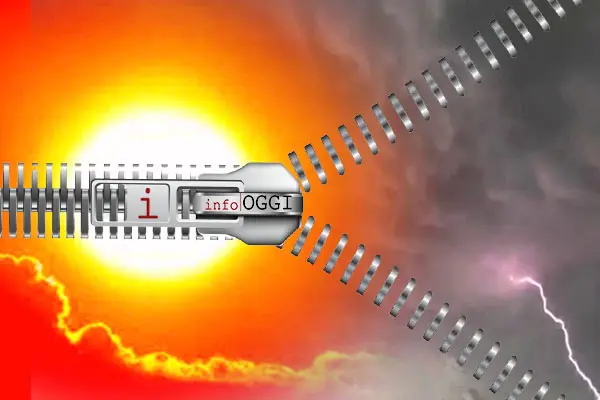Cosa Nostra - Stato, una compenetrazione profonda. Intervista a Enrico Bellavia

Entra nel nostro Canale Telegram!
Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!
PALERMO, 1 OTTOBRE 2012 - Enrico Bellavia è un giornalista e scrittore. Ha collaborato con L'Espresso e Micromega. Scrive per il quotidiano La Repubblica dal capoluogo siciliano. Il giornalismo deve scuotere, incidere, esporre il malcostume e anche raddrizzare i diritti, altrimenti non fa un buon servizio. Tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato c’è una compenetrazione profonda. Gran parte dell’Italia è costruita su logiche e imprese criminali. [MORE]
Giornalismo d’inchiesta, di cronaca nera e giudiziaria; come si diventa cronisti?
Il giornalismo, tutto il giornalismo, è curiosità e amore per il dettaglio. Il cronista coltiva la passione per la ricerca, per il riscontro, per la verifica sul campo. Un giornalista d’esperienza la racconta così: fare il cronista è semplice, basta raccontare quello che si vede, il difficile è raccontare tutto ma proprio tutto quello che si è visto. Credo sia una sintesi efficace.
Cosa significa oggi fare il giornalista d’inchiesta nel territorio palermitano?
Credo che Palermo sia una formidabile palestra, con moltissimi esempi illustri e una tradizione che non sempre riusciamo ad onorare. A me non piace la definizione di giornalista d’inchiesta, lascia intendere che ci sia un altro modo di fare il mestiere. Io credo che ciascuno, nel proprio ambito, e con l’onestà intellettuale che dovrebbe essere un prerequisito di questa attività, possa esercitare quella curiosità e amore per il dettaglio che costruisce una buona informazione. Spesso si confonde il giornalismo cosiddetto d’inchiesta con la cronaca giudiziaria o con la riproposizione di verbali giudiziari più o meno corredati da altri elementi. Quella è onesta cronaca e non c’entra con l’inchiesta. L’inchiesta dovrebbe fornire al lettore una chiave per interpretare una congerie di fatti che sono davanti agli occhi di tutti e che appaiono slegati e distanti. L’inchiesta cuce in una trama unica quei fatti conclusi e ne costruisce uno nuovo, giornalisticamente rilevante.
Quali sono le principali difficoltà del giornalismo d’inchiesta di oggi?
Il tempo. E’ il principale ostacolo a un buon giornalismo. Che richiede tenacia e ore di verifica. La velocità oltre che la riduzione dei budget e un accesso alla professione che preclude l’apporto delle energie migliori attraverso una sana e libera meritocrazia, sono fattori determinanti. Poi c’è il rapporto con il potere che è ostile al buon giornalismo.
Ritiene che esista ancora un giornalismo libero e non censurato?
Nonostante tutto, sono ottimista. C’è una voglia e una richiesta costante di buon giornalismo. Il pubblico è esigente e informato, ha più strumenti per smascherare i bluff e può avere accesso a fonti che spesso coincidono con quelle utilizzate anche da chi fa il giornalista di mestiere. Questo costringe i giornalisti ad esplorare il limite, facendo i conti con la prima iattura del nostro lavoro che è l’autocensura.
Oggi giornalismo è ancora sinonimo di denuncia sociale?
Dovrebbe esserlo sempre. Periodicamente si invoca un giornalismo di buone notizie e va anche bene, ma un giornalismo che non scuota, che non incida, che non esponga il malcostume o provi a raddrizzare la barra dei diritti, non credo faccia un buon servizio.
Cos’è la criminalità organizzata oggi?
Una minaccia costante alla tenuta economica del nostro Paese, dunque alla nostra stessa libertà.
Lei ha intervistato il pentito Di Carlo. Come mai ha sentito questa necessità?
Perché è depositario di una serie di informazioni preziose che sono nei processi e che servono a comprendere meglio la realtà che viviamo. Avevo già raccontato di Di Carlo nel libro Uomo d’onore e intervistarlo su quei temi è stato un’idea perfino ovvia. Lui dice e io sono convinto che sia una lettura dei fatti convincente che tra Cosa nostra e pezzi dello Stato non ci sono stati contatti episodici ma una compenetrazione profonda. Ecco, il punto è questo: l’idea di una trattativa Stato-mafia evoca l’idea di due mondi distanti che entrano in rapporto per un interesse limitato e circoscritto. Io credo, al contrario, che una parte del sistema Paese è costruito su logiche e imprese criminali.
In seguito a quell'intervista ha ricevuto anche minacce. In che modo si sono concretizzate e come le ha vissute?
Ho ricevuto una lettera anonima con l’invito a lasciar perdere. È doveroso denunciare, ma anche collocare una minaccia del genere nel contesto di una reazione rabbiosa di settori che si sentono minacciati dalla verità. Sono cose da non sottovalutare, ma neppure sulle quali costruire una professione.
Un cronista minacciato è spesso vittima d’isolamento e solitudine. Si è mai trovato in questa situazione?
Io ho la fortuna di lavorare in un ambiente attento e vigile. Ho ricevuto tanta solidarietà e per il resto penso che il giornalista abbia un potere immenso che comporta anche dei rischi: è nelle cose e non bisogna correre il rischio opposto che è quello dell’enfatizzazione. Io, ho avuto modo di dirlo, non voglio essere valutato per il numero di minacce ricevute, ma per la qualità del mio lavoro.
Qual era il potere di Bernardo Provenzano e di Totò Riina e perché erano/sono considerati i Capi per eccellenza del sistema mafioso?
Perché erano i capi di Cosa nostra. Riina mantiene ancora quella carica e Provenzano lo ha sostituito rimettendosi alla sua volontà quando, per amministrare il dosaggio sapiente di violenza e convincimento, diceva ai suoi di doversi rimettere a una volontà superiore, quella di Riina. Sono stati dipinti come due analfabeti, arroccati nel loro territorio, dimenticando che anche se di modesti studi, hanno amministrato un potere immenso, fondato sul terrore ma anche su un enorme consenso che gli è stato tributato da settori insospettabili della società siciliana e non solo. Alla loro corte c’era la fila di imprenditori pronti ad entrare nel sistema degli appalti o nella spartizione della torta della grande distribuzione e dei centri commerciali. Per non dire della Sanità, la principale voce di spesa della Regione siciliana. Provenzano ne aveva fiutato le opportunità quando negli anni Ottanta non era assurto al rango di primo ricercato e le sue società avevano già infiltrato il comparto della spesa pubblica per la Sanità dell’Isola.
Il 15 marzo 2012 Angelo Provenzano, figlio di Bernardo Provenzano, per la prima volta ha rilasciato un’intervista al programma Servizio Pubblico di Santoro, suscitando diverse polemiche. Cosa pensa delle dichiarazioni fatte e perché secondo lei il figlio del boss ha sentito il bisogno di darsi al tritacarne mediatico?
Non credo affatto si sia dato al tritacarne: ha provato a rivendicare il diritto a una vita per così dire tranquilla, senza rinnegare il padre. Qualcuno ha letto dei messaggi nelle sue parole. Io credo volesse minimizzare il ruolo del padre e in qualche modo negoziare una sorta di uscita onorevole dal fardello del proprio cognome. Provenzano padre è stato molto attento a evitare che i figli finissero in guai giudiziari e credo che Angelo Provenzano abbia voluto rimarcare senza però mai dirlo esplicitamente la sua intenzione di tenersi alla larga da un’eredità scomoda.
Nel maggio scorso è giunta la notizia del tentato suicidio di Bernardo Provenzano nel carcere di Parma. Pensa che abbia davvero cercato di togliersi la vita o semplicemente è stato un modo per attirare l’attenzione?
Non penso affatto che abbia tentato di togliersi la vita. Per un uomo di quel livello criminale tentarlo significa una dichiarazione di resa. Credo sia stato un gesto dimostrativo, che certo costituisce una novità significativa nel modo di comunicare di questa gente.
Cosa rimane dell’impegno e del sacrificio di tutte le vittime delle mafie?
Rimane la consapevolezza che non si può più dire: non sapevo, non immaginavo. La verità è stata costruita sul sangue di quelle vittime. Va difesa e consolidata, per evitare altri lutti.
Giulia Farneti