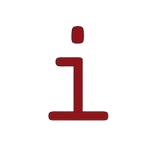InfoOggi Cinema
SPECIALE OSCAR - Spielberg, horse with war name
LOS ANGELES, 21 FEBBRAIO 2012 - Ci sono un inglese, un francese ed un tedesco. Sembra l'inzio di una barzelletta, ma idealmente è il filo su cui ricucire "War Horse" di Steven Spielberg: gli incontri ravvicinati di un equino con gli "uomini contro", di varie nazionalità, durante la Prima Guerra Mondiale. Tra campi lunghi a gogò, su paesaggi di frontiera bellica e su nostalgie Hollywoodiane, ed eroiche cavalcate tra le trincee, Spielberg lascia allo spettatore una cartolina in formato Indiana Jones col cuore: archeologia cinematografica, ma, corpo di mille cavalli, anche gli archeologi hanno l'emozione.
La Grande Guerra, dicevamo, o poco prima. Ma anche un Grande Cavallo: "miracle horse", lo chiameranno. Ai miracoli crede, da subito, il giovane Albert (Jeremy Irvine), figlio di Ted (Peter Mullan), quando vede arrivare nell'appezzamento del Devon il purosangue Joey, acquistato follemente in un'asta col proprietario terriero Lyons. Talento e amore, in quel nitrito da domare, per il figlio; una bestia da ammaestrare ad ogni costo, per i genitori afflitti da debiti, perchè Joey possa diventare un cavallo da soma. Si può fare, si fa: ma "la guerra ha preso tutto a tutti", come si ripete spesso nel film. Ed alla famiglia del Devon porta via il cavallo, venduto al Capitano Nicholls (Tom Hiddleston, giovane purosangue della recitazione), per una vita presumibilmente breve tra biada e mitraglie tedesche.
A horse with war name, per ri-parafrasare una canzone degli America. Perchè la lunga eclissi di Albert dalla storia lascia le redini della scena filmica al cavallo Joey, in sella al quale si percorrono i sentieri selvaggi di un conflitto che diventa il campo di battaglia cinematografica di piccoli ufficiali dalle divise troppo inamidate, soldatini troppo giovani che diventano impavidi fuggiaschi, placide famigliole della campagna francese che passano dal rosso delle marmellate al rosso sangue della guerra, infermerie affollate e trincee fumose.[MORE]
Un inglese: il capitano Nicholls, appunto, che in una sorta di archeologia dell'immagine pre-archeologia degli smarthphone con videocamera, trova il tempo di disegnare un album che ritragga la crescita di Joey, per inviarlo all'ex padroncino. La lealtà: l'ufficiale tiene fede alla promessa di badare all'animale, anche in un contesto dove è fisiologico si badi, piuttosto, alla propria bellaccia. Una scena da incorniciare: la prima offensiva anti-tedesca, Ben-Hur collettivo a cui sopravvive l'eroica corsa di Joey nei boschi, nel fallimento delle velleità inglesi. Gli uomini muoiono, l'horse sopravvive, come la guerra.
Un francese: il vecchio Francois, con la nipotina Emilie, nelle cui stalle finiscono per trovarsi Joey ed un altro cavallo, fiamma equina accesasi tra le fiamme del conflitto. Un lacerto di storia familiare in tempo di guerra - e di famiglia, quella ora composta solo dall'anziano e dall'adolescente: anche qui Joey è il "miracle horse", comparso dal nulla, e subito entrato nei cuori dei nuovi padroni. Il coraggio di andare avanti, nonostante l'orrore: in una sorta di rifondazione dell'umanesimo bellico di Jean Renoir - un francese: casualità? -, il nonno spiega alla nipotina, a fronte dell'invasione dei tedeschi che predano la fattoria, come anche il solo sopravvivere senza atti eroici plateali sia, in tempo di guerra, una forma eroica. Una scena: panoramica avvolgente in campo lungo, che segue Emilie nella prima cavalcata su Joey, oltre la collina, nella reticenza visiva dell'altitudine, nel pericolo silenzioso del vicino accampamento tedesco. "War", come "horse", per alcuni significa "risorsa", per altri continuare la cavalcata della propria esistenza.
Un tedesco: dell'esercito, a cui sono affidati i due cavalli, e la loro liaison animale da inseparabili che prosegue nel mutismo di cannoni trascinati a fatica. La pietà verso il cavallo ferito, che prelude alla pietà verso gli uomini. Una scena: la macchina da presa elegge un carrarmato a carrello, facendolo avanzare. Il cavallo cerca via di scampo, accerchiato dalla recinzioni. La trova saltando sul mezzo, sorta di moloch cingolato: come sarebbe bello saltare a piè pari la guerra. Tutti cavalli da soma in guerra, nell’imposizione del sacrificio – una traslazione dal cavallo all’uomo. E poi, dall’uomo al cavallo: traslazione di un desiderio di libertà, ed il soldato tedesco vorrebbe affrancare, di nascosto, l’animale, sotto ad un ponte, mentre la marcia dei colleghi di morte non è mai stata tanto marziale. “War” è l’anagramma di “raw”, lo stato naturale, selvaggio degli animali.
Qualcuno già si solleva, tiepidamente sdegnato, contro la retorica di Spielberg, il regista-archeologo, il filmaker che filma Hollywood anche quando la macchina da presa si sposta sulla Somme, il cineasta della Disney che fa film per famiglie senza sciogliere le briglie di uno sguardo emozionato. Si dimentica, forse, che non tutti sono dissezionatori di cadaveri, quando guardano un film: dove un critico vede John Ford, uno spettatore sente il vento sulle tempie di un paesaggio slontanante nella bellissima fotografia di Janusz Kaminski; dove il professionista rivive il rendez vous con le trincee di Kubrick, l'osservatore ancora malizioso si barcamena nel gas letale dei terrapieni, che per lui non è fumo negli occhi; dove il (re)censore\storico-del-cinema pensa al soldato Ryan, il mangiatore di film si salva, per sua fortuna, pensando al cavallo Joey, alle sue pezzature bianche delle zampe che s'infangano in cavalcate interminabili, nella stessa mota in cui, nostro malgrado, i continui cambi di fronte visivo e diegetico ci sballottano fisicamente.
Anche un sonetto di Shakespeare è scritto nell'estremo controllo del metro, ma ciò non toglie che il lirismo sia soffocato. Candidato agli Oscar, "War Horse" di Spielberg non vincerà, e stando alle prime reazioni, non si è nemmeno fatto strada tra le viscere di una critica forse troppo intellettuale. Ma laddove alcuni hanno voluto scorgere uno sguardo troppo bovino nell'equino Joey, a me - e fidatevi: a tanti altri - è parso di vedere un umanissimo coacervo sentimentale, più che sentimentalista: il baricentro mobile, come un mirino spostato ripetutamente, di microstorie, speranze ostinate, (e)motion pictures. La No man's land in cui Joey corre, libero nel dolore e nella morte, ferendosi nel garbuglio dei fili spinati, è davvero "no man's" fintantochè a scene così si guarderà col microscopio, nell'oggettività spersonalizzante della scienza fimolologica, dove l'umanità di carne e sangue del film sparisce: piuttosto che col binocolo curioso ed impaurito - come i soldati della trincea inglese - di uno sguardo irritabile ed umorale, intriso di polvere. Una cenere dai percorsi studiati, più che dalla danza libera: ma come impedire a Spielberg di essere un regista che ama la regia? Più che chiamarla stucchevolezza, dovremmo "amare" - e farci male - a nostra volta.
Così, proprio come al soldato tedesco ed a quello inglese che liberano il cavallo dalla corona ferrata di spine, capiterà di trovare un'anima nella guerra del film, laddove a qualcuno è magari successo di vedere solo risorse filmiche prese qua e là; e soprattutto, qualcuno si ricorderà di Ford, non per riesumare cadaveri, ma per cavalcare i sentieri selvaggi dell'immagine cinematografica. Purchè la guerra, che "ha preso tutto a tutti", ad alcuni non abbia anche preso la sella - e la capacità di emozionarsi.
Antonio Maiorino