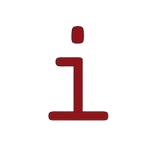InfoOggi Cinema
La hija de un ladrón, intervista a Belén Funes: la mia Sara, donna di cristallo con l'armatura
Per la rubrica UNCUT GEMS – diamanti grezzi, La hija de un ladrón di Belén Funes: le interviste di Antonio Maiorino sui migliori film d’autore del cinema contemporaneo mondiale. Spesso, inediti (in Italia), non ancora “sgrezzati” dallo sguardo dello spettatore; spesso, autentici gioielli nascosti.
È un esordio destinato a rimanere nella memoria cinematografica, e pare che ai Premi Goya se ne siano accorti, se in Spagna La hija de un ladrón è valso alla regista Belén Funes il riconoscimento quale migliore regista esordiente. Anche in Italia se ne parla da qualche settimana: il film ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria alla 66esima edizione del Taormina Film Fest. E tacciamo degli altri premi, perché urge parlare del film: storia di vita urgente, raccontata con profondo realismo, impatti ben assestati e penetrante senso della verità. Greta Fernández, talentuosa attrice spagnola (Concha de Plata per questo ruolo al Festival di San Sebastián), recita col padre, il navigato interprete Eduard Fernández, e nel film sono proprio figlia e padre.
LA TRAMA DEL FILM LA HIJA DE UN LADRÓN (QUI IL TRAILER)
Sembra lui. Aspetta: sì, è proprio lui. Sara, giovane madre single, scorge una sagoma familiare all’agenzia di lavoro dove si sta arrabattando per trovare un’altra occupazione e guadagnarsi il pane. Il padre compare così: nello sguardo quasi atterrito della figlia, che non appena scorge il genitore, si allontana precipitosamente, mollando persino la carrozzina dell’infante, tanto è sgradito il rendez-vous inatteso. Non devono avere un buon rapporto, ma Sara ha imparato – o sta imparando – a sopravvivere, praticamente senza una famiglia: il compagno, Dani, compare una tantum, per lo stretto indispensabile; il padre Manuel, pare fosse in carcere; la madre chissà. E il fratellino Martin? Mentre cerca di fare la madre e la lavoratrice, Sara pensa di chiederne la custodia: ma questo vuol dire anche fare i conti con quel ladron del padre. Che complica terribilmente le cose, perché sa anche sorridere teneramente.
PERCHÉ INNAMORARSI DEL FILM LA HIJA DE UN LADRÓN
Andrebbe rivisto più volte, il film di Belén Funes, per coglierne la ricchezza di dettagli dal piglio quasi documentario, ma basta la prima visione per lasciarsi attrarre dall’impulso vitale che Greta Fernández, di concerto con la regista e la squadra tecnico-creativa, riesce a conferire al personaggio di Sara con un’interpretazione potente e credibile. Quasi fiore nel deserto emotivo della non-famiglia, una ginestra aggrappata alla vita, Sara vive le battaglie di ogni giorno cercando di ritagliarsi un orizzonte di speranza, e seguirla con la macchina da presa significa ondeggiare tra il tono volutamente prosaico delle naturali faccende di ogni giorno, e la stordente intensità emotiva di scene di forte impatto: una doccia nuda col neonato, i pentoloni lavati alla meglio e con olio di gomito nelle retro-cucina del ristorante, un diverbio col genitore in una casa-trappola, un finale sul filo di quella tensione che anche le parole sussurrate sanno urlare.
INTERVISTA A BELÉN FUNES
ANTONIO MAIORINO: il percorso de La hija de un ladrón parte da molto lontano, trovando forse la propria gratificazione principale nel Premio Goya 2020 come migliore regista esordiente. Di recente, il film ha ricevuto una menzione speciale al Taormina Film Festival e vorrei leggerti la motivazione: “La Giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale a La hija de un ladrón di Belén Funes (Spagna), un'opera prima moderna, di grande potenza, con la direzione di un gruppo di attori straordinari, che racconta la battaglia per la sopravvivenza economica e affettiva quotidiana”. Ti domando: manca forse la sottolineatura del fatto che questa storia di resistenza fosse una storia di resistenza femminile? È un elemento imprescindibile?
BELÉN FUNES: forse non direi imprescindibile, ma per me era evidentemente molto più facile parlare di una donna che di un uomo per il semplice fatto di essere una donna... eppure è curioso che il film sia stato scritto con un uomo (Marçal Cebrian, n.d.R.). Volevo che il film fosse centrato su una donna perché ho la sensazione che spesso nel cinema le donne siano concepite come le amanti dei protagonisti, che servono a spiegare qualcosa sulle controparti maschili, e mai a raccontare sé stesse. Mi entusiasmava l’idea che il racconto si incentrasse su una donna anche perché in Spagna c’è un certo numero di donne madri e single. La conclusione a cui siamo giunti è che queste madri sono giovani, sole, senza un compagno con cui condividere la maternità, e che abbiano moltissime difficoltà economiche, soprattutto nell’accedere a posti di lavoro ben remunerati o con orari normali e degni. La battaglia per la sopravvivenza, dunque, doveva avere una donna come protagonista, per corrispondere a ciò che succede di questi tempi in Spagna, e che suppongo essere simile in Italia.
A.M: quando un cinefilo vede un film, spesso pensa ad altri registi che possano aver influenzato il regista del film in questione. In questo caso, vien da pensare ai Dardenne o a Ken Loach; per aggiungere da parte mia dell’italianità, posso arrivare fino al Neorealismo. A volte, però, dimentichiamo che l’arte non si nutre solo di altra arte, ma anche della realtà. Che lavoro di documentazione hai fatto prima del film? In particolare, di tutto ciò che hai scoperto, cosa hai selezionato perché confluisse nel film?
B.F: Abbiamo svolto un processo di documentazione durato quasi un anno nel quale siamo stati con gente che lavorava per i servizi sociali della mia città nei centri di accoglienza dei minori o negli appartamenti per la tutela di madri single. Ci spiegavano il profilo di queste donne, il loro presente immediato e il futuro prossimo. Dopo un primo giro di domande a quelli che nei servizi sociali hanno il potere, o meglio, la gestione, ci siamo poi volti a prendere contatto con le ragazze stesse, riscontrando molte situazioni simili a quelle di Sara. Una delle prime cose che abbiamo notato è che tutte avevano un neonato. All’inizio nel film la protagonista non doveva avere un figlio, ma abbiamo visto che nella realtà molte di queste ragazze ce l’avevano. Allora abbiamo cominciato a chiederci come fosse possibile che una donna che si trovasse in tale situazione di precarietà e nella massima difficoltà economica decidesse di avere un neonato. Quello che loro mi spiegavano, e che io stesso sono arrivata a capire, era la volontà di dare alla famiglia e alla vita una seconda opportunità, di mostrare a loro stesse che si potesse avere un figlio a cui voler bene e di cui prendersi cura e che fosse possibile farlo bene. Questa è stata la scoperta più importante: prive di riferimenti familiari, queste donne avevano l’anelito di formare una famiglia propria. A partire da questa idea, abbiamo articolato e strutturato il film. Sara vuole solo che la amino e vuole avere una famiglia: è poco, ma allo stesso tempo è tutto per lei.
A.M: a questo punto non posso fare a meno di venire alla protagonista, Sara, interpretata da Greta Fernandez. Quello di Greta è un personaggio reattivo, che riesce ad esprimere molto anche quando non parla, recitando col corpo. Quali sfumature del suo carattere si possono intuire al di là dei dialoghi e quale pensi sia stata la scena più “fisica” del film?
B.F: Sara è una donna forte che si confronta con la vita con violenza ma che in fondo è fragile. Questo miscuglio tra energia e fragilità mi sembrava fondamentale per il suo personaggio. Sara è determinata e proiettata in avanti e allo stesso tempo ha bisogno che la amino, è come una statuina di cristallo in una potente armatura. Quanto alla seconda domanda, c’è una sequenza in cui sta pulendo, ha appena incontrato il padre fuori la scuola in cui lavora e sviene, ma più che svenire, le mancano le forze per la stanchezza, per il carico di tensione. È stato molto difficile per Greta e anche per me, perché dovevamo trovare il momento giusto per farle mancare le forze, proprio per far capire che non era un semplice svenimento. Molto difficile è stato anche il finale, in cui si disvela tutto del personaggio; è stato difficile anche per l’attrice, ma penso che alla fine siamo riusciti a tirar fuori qualcosa d’interessante.

A.M: attore a suo modo importante, e attore inconsapevole, è il neonato, il figlio di Sara nel film. Con un neonato, le produzioni diventano più complicate: perché per te è un valore aggiunto?
B.F: hai trovato le parole migliori: valore aggiunto. Quando devi spiegare a una produzione che ti serve un neonato per il film, devi essere in grado di far capire come si trasforma il film. Ti faccio un esempio. Immagina una donna di 21 anni che cammina per strada; ora immaginala con un neonato. Sono due immagini completamente diverse, due personaggi totalmente distinti. Entrambe validi, beninteso, ma ne cambia la lettura: una è una ragazzina con un bebè, l’altra è solo una post-adolescente che cammina per strada. L’idea del neonato nel cinema mi piace perché i film si tingono di realtà. Se riesci a farci un buon lavoro, possono essere molto spontanei e conferire grande tenerezza, aprendo le porte del realismo all’immagine cinematografica. Il neonato, naturalmente, non si può dirigere, fa quello che vuole in ogni momento. Quello che noi siamo riusciti a fare è stato creare una mini-storia con Greta. Quando Greta e il neonato si sono conosciuti, c’è stata subito tantissima chimica. Per esempio, c’è stato un momento delle riprese in cui Sara\Greta, durante la cena, non fa caso al figlio, e lui cerca la sua attenzione, dandole uno schiaffetto. Si avverte che c’è una storia nella storia, che tra madre e figlio c’è un presente e un passato condivisi. Poi, certo, girare con un bebè aggiunge molta difficoltà, perché ci si può lavorare solo un paio d’ore e devi avere quelli che noi chiamiamo “backups”, sostituti: se succede qualcosa al neonato, per esempio, che ha la tosse, è chiaro che non può venire alle riprese, perché bisogna prendersene cura e farlo stare bene innanzitutto. E intanto, il tempo ti rema contro. Per fortuna, noi abbiamo trovato un neonato molto socievole e amichevole, Dylan. Fare un casting di bebè significa scoprire quale sia il più socievole: anche questo tipo di attore non può essere uno qualsiasi.
A.M: adesso una domanda che unisce i due personaggi, madre e figlio. Nella prima scena domestica, vediamo Sara che si pettina e sentiamo piangere il neonato, ma Sara, invece di prendersi cura del bebè, lo lascia piangere e alza il volume della musica sullo smartphone. La prima immagine di madre che abbiamo di lei nel film è lungi dall’essere perfetta. Il film parla di Sara come figlia, ma in che modo l’hai tratteggiata come madre?
B.F: l'ho descritta nello stesso modo come figlia e come madre, ossia, senza gli strumenti per essere sia l’una che l’altra. Come figlia, non ha gli strumenti per relazionarsi col padre perché lui non ha mai saputo amarla; come madre, non ha strumenti per relazionarsi col figlio, perché ritiene che avere un figlio voglia dire mantenerlo pulito, fargli il bagnetto, dargli da mangiare, e tutto questo lo sa fare bene. Non ha compreso, però, che avere un figlio vuol dire creare un vincolo emozionale. Non mi piace quando nel cinema si carica la donna dell’incombenza di dover essere una donna perfetta per tutto il tempo. Non conosco nessuna madre che lo sia. Ciò che più m’interessa è che il cinema sia un riflesso dei personaggi attraverso ciò che fanno. In questo caso, comprendi il personaggio di Sara dal modo in cui cerca la maternità e da ciò che le manca. Ecco, La hija de un ladrón è un film su ciò che manca, piuttosto che su ciò che si ha. Quello che manca a Sara è imparare ad amare, a sapersi relazionare col sangue del suo sangue, perché è quello che da sempre è mancato a lei.
A.M: chi pretende d’insegnare a scrivere storie, anche storie di cinema, afferma spesso che bisogna mettere i personaggi nella propria area di rischio, in una zona di pericolo. Nel colloquio di lavoro al ristorante, il datore di lavoro fa una domanda apparentemente pericolosa: “chi sei? Come ti definiresti?”. Eppure, Sara incassa tranquillamente, dicendo di essere una persona “normale”. Si sta difendendo dall’attacco dello sceneggiatore che prova a metterla in difficoltà, o semplicemente non è la sua zona di pericolo? Quali altre trappole le avete preparato per raccontarne la storia?
B.F: abbiamo cercato di mettere Sara in molte situazioni scomode, ma ci siamo resi conto che sapeva risolverle rapidamente. È stato un problema per la scrittura della sceneggiatura. Nel colloquio di lavoro che citi, lei dice di essere molto lavoratrice, ma non lo fa perché vuole vendersi: è la verità, lo si è visto nella prima parte del film, è la migliore lavoratrice che ci sia. Quando le chiedono chi sia e come si definirebbe, lei dice di essere normale, sì, ma è una bugia. Lei è un caso straordinario: solo una su un milione nella sua situazione riesce ad andare avanti. Le piacerebbe, però, restare anonima, avere una vita normale, una famiglia. Mentre scrivevamo la sceneggiatura ci siamo resi conto che Sara è una grande bugiarda, ma questo doveva venir fuori solo in brevi momenti. Il momento più bello è quando dice che non la chiama mai nessuno, perché è un momento di schiantante sincerità. La situazione più scomoda per lei è quella di dover dire la verità e doversi spiegare così com’è. Il viaggio lungo il film è come un esercizio di sincerità verso sé stessa.
A.M: l’altro personaggio chiave è quello del padre, interpretato da Eduardo Fernández, padre di Greta nella vita. Non ti farò domande sulla recitazione di padre e figlia sul set, suppongo te lo abbiano già chiesto in molte altre interviste. Ciò che m’interessa è che parlare di un ladrón nel titolo sembra quasi infliggere una condanna precoce, come a dire: sarà lui il cattivo. Era così, oppure durante il film lo spettatore viene spiazzato da molte altre sfumature drammatiche, che rendono il padre più complesso rispetto alle attese generate dal titolo?
B.F: col titolo volevamo dare la sensazione che la figlia di un ladrón è sempre la figlia di un ladrón, nel senso che non si può cambiare il padre. Sei figlio di chi sei figlio e questo maneggia il tuo futuro in qualche modo così come la persona che sei. Quello che m’interessava è che il personaggio di Manuel, interpretato da Eduardo Fernández, fosse un po’ vittima di sé stesso, che avesse reso i figli dei disgraziati ma che per lui nemmeno fosse stato facile. C’è un momento del film in cui Manuel accenna al fatto che la madre si trova a Jaén e lui valuta di raggiungerla: questo ci apre un mondo, capiamo che anche lui ha avuto una relazione difficile con la madre, di abbandono, e vuole vederla affinché siano madre e figlio. Di fondo c’è questa idea ciclica della relazione tra genitori e figli, per cui i comportamenti li ereditiamo, li impariamo e li applichiamo a nostra volta coi nostri figli. Volevo che il padre apparisse come un tipo che non sa gestire le proprie responsabilità, ma volevo anche che per lo spettatore fosse chiaro che a sua volta ha avuto difficoltà filiali, e non a caso è ciò che è: il prodotto di un vissuto caratterizzato dallo sradicamento del rapporto con la madre.
A.M: tra le preoccupazioni di Sara, c’è quella che il fratello Martin, forse proprio ereditando il comportamento del padre, faccia parte di questo universo maschile sostanzialmente fallito: il padre che non sa come fare il padre, il compagno assente e, appunto, lo stesso fratellino che fugge di casa e crea non pochi grattacapi. Come hai profilato l’universo maschile del film La hija de un ladrón?
B.F: credo che il mondo maschile del film sia pieno di difetti: padri che non sanno fare i padri, fratelli che non sanno relazionarsi alle sorelle... Ma quello femminile, altrettanto: Sara, ad esempio, non riesce a rapportarsi al proprio compagno Dani (l'attore è Àlex Monner, n.d.R.) e capire che lui non vuole esserne il suo compagno. Benché Dani mantenga un impegno con lei e col figlio, non vuole fidanzarsi e mai lo vorrà. Che lei sia incapace di accettare questa realtà, è indicativo dei suoi difetti caratteriali. È un po’ come se tutti i personaggi riuscissero a sopravvivere, ma nessuno riuscisse a funzionare bene. Non volevo fare un film su quanto siano brave le donne e cattivi gli uomini. Dani mi piace molto come personaggio perché ha deciso di non essere il ragazzo di Sara ma resterà con lei e col bimbo per tutto ciò di cui ci dovessero aver bisogno. Curiosamente, quando ho presentato il film c’è stata molta gente che si è arrabbiata per il fatto che Dani non volesse stare con Sara, ma è qualcosa che può succedere il fatto che un uomo, preservando la propria libertà sessuale, decida di non stare con una donna.

A.M: diverse settimane fa Mark Jenkin, regista di Bait, mi ha detto durante un’intervista: “io ho già il film nella testa prima di cominciare a girare”. Mi chiedevo se questa idea fosse compatibile con l’uso della camera a mano, che contraddistingue il tuo film. Con la camera a mano, bisogna saper selezionare i momenti giusti, che possono anche essere momenti morti, e non di azione. È qualcosa che il regista può comprendere solo nel presente fisico in cui comincia le riprese, che sorge nel post- del montaggio, o che è scritto nel pre- nella sceneggiatura?
B.F: tutto ciò che c’è nel film era anche nella sceneggiatura, ma come sempre succede, la sceneggiatura è parola scritta, il film immagini in movimento. Faccio un esempio molto semplice. C’è una sequenza in cui Eduardo regala degli orecchini al figlio. È stata una delle migliori scene del film e una delle migliori cose che girerò in tutta la mia carriera di regista. Di una tenerezza incredibile, adoro ciò che fa il ragazzo. Questo nella sceneggiatura è scritto in una frase: Manuel regala degli orecchini a Martin. Quando filmi questa frase, si converte in un universo e consegue una corporeità che la sceneggiatura non può avere e che invece l’immagine possiede. Per lo spettatore ingenuo il film coincide con la verità, ma in realtà è solo una rappresentazione di qualcosa che potrebbe accadere in quel modo nella vita reale. Nel film c’è molta poca improvvisazione. Ho scritto tutto, tranne la parte che riguarda il neonato, che non aveva sceneggiatura. Quello che ho fatto è stato mettermi io stesso accanto alla macchina da presa per suggerire le battute a Sara e poi poter montare. Girare con bambini è complicatissimo, devono stare bene e bisogna trovare stratagemmi di questo tipo. In generale la camera a mano, deve essere flessibile, perché non hai un campo definito e devi cogliere momenti di realtà. Credo che essere flessibili al momento di decidere inquadrature e posizioni, significhi partire da ciò che fanno gli attori. Il lavoro è inverso: metti gli attori in situazione e vedi come si muovono nella forma più naturale, poi ti metti alla macchina da presa e filmi. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non avevo tutto il film in mente sin dall’inizio, ma non ho nemmeno lasciato semplicemente che le cose accadessero: ho fatto in modo che succedessero. Questa è stata sempre la mia domanda: cosa posso fare nelle riprese affinché io riesca a filmare un determinato momento.
A.M: lo spettatore ingenuo. Ecco, volevo chiederti proprio di quest’ultimo. Amo spostarmi dalla prospettiva del regista a quella dello spettatore. Questo ipotetico spettatore ingenuo potrebbe dire che un film con questo stile visuale, con poco trucco, senza colonna sonora, molto realistico, ponga poche difficoltà nelle riprese. Cosa gli risponderesti? Come gli racconteresti di tutte le difficoltà di una produzione di questo tipo?
B.F: non lo pensano solo gli spettatori ingenui. Ti lascerei di sasso se ti dicessi che qualche critico affermato ha detto cose del tipo: “tu che hai messo la camera a fare riprese” ... Non si capisce che il film è frutto di una costruzione e per alcune inquadrature avevamo anche 17-18 riprese diverse. La difficoltà principale quando vuoi ottenere un effetto naturalistico e realistico è di dover avere, in quanto registi, una sorta di sensore radar. Vedi un’immagine in uno schermo piccolo e il tuo radar mentale deve dirti se ci credi o no. Non smetti di riprendere finché non ci credi. La prima ripresa non funziona mai, perché gli attori fanno ancora qualcosa di molto cinematografico, allora ti fermi, torni alla situazione iniziale, e continui a farlo finché per il tuo sensore radar non appare come la realtà. Sembra che il trucco non ci sia, ma c’è; sembra che l’illuminazione non ci sia, ma c’è un grande lavoro di illuminazione; c’è anche un lavoro sul suono lungamente progettato. C’è una capo-costumista che ha disegnato i costumi per tutti i personaggi. Il naturalismo e il realismo devono essere generati nello stesso modo in cui in un film d’azione generi la suspense.

A.M: incalza lo spettatore ingenuo: con l’agio di un budget maggiore, avresti fatto le stesse cose?
B.F: avrei fatto lo stesso. Al film non manca niente. (Si ferma a pensare, n.d.R.). Sì, al più avrei comprato una canzone di un cantante spagnolo che si chiama Camarón de la Isla, cantante di flamenco. Ma in fin dei conti, con più soldi non avrei potuto fare questo film, è frutto di uno sforzo collettivo. Con più soldi avremmo comprato solo la tranquillità e tolto qualche preoccupazione, ma non so se avremmo fatto un film migliore.
A.M: sforzo notevole di produzione è anche quello dei cortometraggi. Il personaggio di Sara sembra anticipato dal tuo corto del 2015, Sara a la fuga. Spesso si considera il corto come un passaggio formativo di giovani registi che poi, quando potranno, faranno solo lungometraggi. Considerando che vivi la scena spagnola, che è molto vivace in fatto di talenti del corto, te la sentiresti di smentire questo luogo comune, chiaramente ingeneroso?
B.F: l'altro giorno sono stata giurata in un festival di cortometraggi internazionali in Galizia e ti assicuro che ero stata in festival di lungometraggi che non raggiungevano questo livello. Nel caso del cortometraggio spagnolo, negli ultimi anni ha avuto una crescita clamorosa: siamo arrivati a vincere a Cannes con Timecode di Juanjo Giménez. È inesatto affermare che il cortometraggio sia il fratello minore del lungometraggio, per me è quasi come il padre. Hai la libertà di provare un sacco di cose che confluiranno poi nel primo progetto sul lungo formato. Bisogna rispettare il cortometraggio, e amarlo molto. Sono stata regista di cortometraggi, prima del mio primo lungo, e ne ero profondamente orgogliosa. È un lavoro immane che la gente non conosce, e costa molto quando non disponi dei mezzi necessari. Credo che il problema sia che la produzione di cortometraggi sia molto abbondante e all’interno di questa produzione ci siano tanti film che, in effetti, valgano poco. Altri, però, sono progetti piccoli e umili di un livello che farebbe gola a tanti festival di lungometraggi. In Spagna ci sono cineasti molto bravi che fanno corti, e che faranno, a mio avviso, alcuni tra i migliori dei lunghi dei prossimi anni. Parlo di registi come Alvaro Gago, che ha fatto un primo corto, Matria, un secondo, 16 de Decembro, e ora sta sviluppando un lungometraggio, e a me sembra che già quelli fossero film incredibili. Massimo rispetto per il cortometraggio.
A.M: in realtà era un modo per tornare a La hija de un ladrón sotto un altro punto di vista. Le strategie di un corto sono diverse da quelle di un lungo. Ne La hija de un ladrón c’è una battuta conclusiva fulminante, che naturalmente non svegliamo. È interessante però notare che il finale è così impattante perché l’impatto è stato preparato, come fossero attacchi multipli: un modo di fare cinema diverso da quello più “esplosivo” del cortometraggio. Come riuscirci, mantenendo allo stesso tempo il film come massa compatta, e non come sequenza di episodi, somma di corti?
B.F: non è un tipo di cinema che ho inventato io, è la tradizione europea. C’è una differenza tra avere un personaggio a cui succedono disgrazie, una concatenazione di disgrazie, e avere un personaggio che cerca di aggrapparsi alla vita. Sara cerca di recuperare il suo compagno, di trovare un lavoro, di divertirsi, di salutare l’unica amica che ha avuto, sua compagna di appartamento, e così si costruisce quella massa compatta, che non impatta sul personaggio, perché è piuttosto lei che impatta sulla realtà: si fa strada, si muove, è il motore, non sono le cose a succederle. Le cose in sé non valgono niente, vale ciò che lei fa. Per questo arrivi al finale e sei stanco come lei perché lei ha fatto tante cose durante il film e tu l’hai fatto con lei. È un personaggio che si muove, che si guadagna ogni centimetro di terra. Questa grande domanda finale, che non sveleremo, contiene tutto il film e non vale la pena rispondere, perché condensa tutta la sua lotta, e non ha bisogno di risposta da parte di nessuno.
A.M: d’altro canto, nel montaggio sonoro del film, ci sono rumori fuori campo su schermo nero sia all’inizio che alla fine, come a fare della storia del film un frammento di vita.
B.F: l’ispirazione dal punto di vista sonoro viene da Elephant di Gus Van Sant, che comincia nello stesso modo e il cui senso è questo: succedono cose nella vita ma la vita va avanti. Abbiamo voluto creare qualcosa di simile col suono, suoni decontestualizzati da una realtà che già sta funzionando quando arrivi a vedere il film, e far finire la storia con una realtà che continua a funzionare quando il film finisce: s’interrompe quel pezzo di vita, anche se non sei arrivato a una conclusione.
A.M: di Elephant, tra l’altro, mi pare di osservare che hai colto anche le inquadrature di spalle che seguono i personaggi: ne fai molte su Sara, di questo tipo.
B.F: sì, Elephant è sempre stato un’ispirazione.
A.M: qualche anno fa intervistai Paula Ortiz, due premi Goya col film La novia. Lei mi disse testualmente: “i grandi studi e le grandi televisioni, peraltro senza ragioni obiettive, non concedono fiducia affinché le donne si sobbarchino questo peso. Per esempio, un film della Marvel negli Stati Uniti, o grandi film prodotti dalla Atresmedia o 35 in Spagna non sono affidati alle donne, perché a volte si continua a pensare che le donne facciano buone pellicole, ma piccole, intime, fondate sull’aspetto emozionale: quando poi, tutto il cinema si basa sulle emozioni”. Sono passati quattro anni. Sei d’accordo in base alla tua esperienza?
B.F: in Spagna, quando le donne si presentano per chiedere sostegni finanziari per i propri film, ottengono generalmente aiuti selettivi, cioè quelli in cui si dà meno denaro. Solo poche riescono a ottenere più fondi. Questo vuol dire che la maggioranza di noi donne sta facendo piccoli film. Io faccio il cinema che voglio fare. Mi piace e mi trovo a mio agio con questa etichetta di cinema intimista. Tuttavia, non possiamo dare per scontato che tutte vogliano fare questo: ci sono anche registe che vorrebbero girare James Bond, ma non ci riescono perché c’è uno status quo per il quale le donne possono avere accesso solo a un certo tipo di budget. Quel budget può bastare se il film è La hija de un ladrón, ma se vuoi fare Avengers, non ci riesci, perché è chiaro che ti servono molti più soldi. Ora si sta cercando di invertire questa tendenza. Alcuni, soprattutto uomini, diranno che già ci sono donne che fanno film di supereroi, ma il fatto che Wonder Woman sia stato girato da una donna non vuol dire che la tendenza sia stata invertita. “Ci sono donne che girano film per la Marvel”, dicono, ma non è così: c’è una donna, ce ne vorrebbero di più. Inoltre, una cosa che percepisco, è che quando sei donna e vuoi fare un film, non ti puoi sbagliare: devi fare un film incredibile. Se sei maschio, puoi puoi sbagliare, avrai altre opportunità in cui potrai rifarti di questi errori e continuare a mostrare alla gente che vali. È un’opportunità che noi donne non abbiamo. Questa che mi hai fatto è una delle poche interviste in cui mi chiedono come hai usato la camera a mano, come hai scelto gli attori, come hai scritto la sceneggiatura; in genere mi domandano “che significa essere donna in un mondo di uomini”, ma non m’interrogano mai sul mio lavoro da regista. Eppure, io ho diretto un film, prima ancora di essere donna, e per questo ti ringrazio dell’analisi che hai fatto. Non succede spesso che mi chiedano del film. Le donne vogliono forse parlare solo di altre donne? Ma no! Le donne vogliono fare solo film piccoli e intimisti? Macché! Bisogna cambiare questo modo di pensare e non ci siamo ancora riusciti.
A.M: e il cinema spagnolo ci sta riuscendo?
B.F: ciò che sta succedendo nel cinema spagnolo è che molte registe stanno facendo la propria comparsa sulla scena. Sono state avviate politiche che hanno fatto in modo che le donne potessero farlo e in più c’è il contributo impagabile delle università. All'università non sei né uomo né donna, sei semplicemente un alunno e quindi senti di poter accedere alle stesse opportunità dei tuoi compagni. O almeno mantieni questa illusione finché studi.
SCHEDA DEL FILM
Titolo originale: La hija de un ladrón
Genere: drammatico
Durata: 102'
Regista: Belén Funes
Sceneggiatura: Belén Funes y Marçal Cebrian
Produttori: Oberon Cinematografica e BTeam Pictures
Cast: Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner, Frank Feys
Fotografia: Neus Ollé-Soronellas
Montaggio: Bernat Aragonés
Scenografia: Marta Bazaco
Costumi: Desirée Guirao
Pagina ufficiale
(IMMAGINI, FONTE BTEAM PICTURES: nell'immagine principale, fotogramma dal film con Manuel al centro, Sara a destra e Martin a sinistra; all'interno, prima immagine: Sara col figlio in doccia in un fotogramma del film; seconda: Dani e Sara in un fotogramma del film; terza: Belén Funes a destra con un'operatrice durante le riprese)