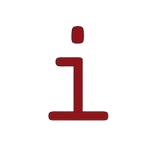Estero
Iraq, il paradiso dei Signori della guerra
Da circa un anno gli Stati Uniti se ne sono andati, così come telecamere e taccuini degli inviati delle grandi testate giornalistiche del mondo. Eppure mai come oggi, probabilmente, il nuovo corso dell'Iraq meriterebbe attenzione, mediatica e non. Perché nel buco nero lasciato dalle organizzazioni governative sovranazionali e dalla stampa si sta delineando il fallimento di uno stato, stretto nella doppia morsa degli scontri etnici e di una vera e propria guerra tra contractors.
BASSORA (IRAQ), 19 NOVEMBRE 2012 - «Ed ora abbiamo un'arma chimica ad aria mai usata. Morte garantita in 3 minuti. Cosa offrite per questo miracolo della scienza moderna? 20...20...20...20...20...Aggiudicato! Il prossimo: che ne dite di questo bel pezzo con la punta di uranio della serie speciale “Spara e Dimentica”? Allora non per 1000, non per 900, non per 800, non per 700, non per 600, vogliamo cominciare da 500 dollari?[...]Venduto a 26 dollari!»
A questa speciale “battuta d'armi” partecipava - come regista - Michael Moore, che la inseriva nelle prime fasi del suo Operazione Canadian Bacon del 1995, secondo film in assoluto – primo e per ora unico tra quelli di finzione - per uno degli esponenti più in vista della “coscienza critica” americana e mondiale poi rivelatosi al grande pubblico con The Big One (1997), Farenheit 9/11 (2004) o Capitalism: a love story (2009).[MORE]
Scena simile c'è stata lo scorso 17 ottobre a Washington, dove l'hangar pieno di armi del film di Moore è stato sostituito da camere di alberghi a cinque stelle, abiti eleganti e contratti da firmare. Non è la scena di un film, ma il resoconto ridotto all'osso dell'International Stability Operations Association, la conferenza annuale dei “Signori della Guerra”, riunitisi a pochi passi dalla Casa Bianca con l'intento – per niente celato – di spartirsi i guadagni del settore bellico e terminare l'opera di privatizzazione della guerra iniziata dall'Iraq e continuata in scenari di guerra conclamata come la Libia o l'Egitto così come in paesi quali l'Inghilterra, dove – come scriveva “OsservatorioIraq” – il premier David Cameron si è rivolto ad una compagnia di sicurezza privata come la Kroll per sapere come gestire le proteste di piazza scoppiate nelle vie di Sua Maestà.
Un affare di Stato. Delocalizzare la guerra ma non il commercio di armi. Sembra essere questo il leitmotiv delle politiche globali al tempo della crisi, con il nostro paese che, tra i primi dieci paesi acquirenti, per i prossimi dodici anni spenderà una cifra stimata in 230 miliardi di euro in armamenti da guerra. Cifra che comprende anche i mai troppo osteggiati F-35 per il cui acquisto la Difesa sarà costretta a licenziare personale civile e militare e che rappresenta solo una parte di quei 1.700 miliardi di dollari spesi globalmente lo scorso anno nel commercio di armi, come denunciano Duccio Facchini, Michele Sasso e Francesco Vignarca nel libro “Armi, un affare di Stato”l. Una cifra superiore al doppio del budget delle Nazioni Unite.
Pomodori, mandarini, bombe a mano, lanciamissili. Duemila dollari per un kalashnikov, mille in più per una mitragliatrice BKC, stipati nei cofani di autovetture o camion, tra la frutta e la verdura che riempie i mercati.
È questo quello che ci si trova davanti – in una scena non così dissimile da quella raccontata da Michael Moore – nel mercato nero delle armi in Iraq, paese ormai cancellato dall'agenda giornalistica occidentale nonostante le forti tensioni interne e lungo i confini, in particolare sul caldo fronte siriano (ad ovest) e su quello orientale con l'Iran, potenzialmente esplosivo. Chiave di lettura interessante per capire questo periodo potrebbe essere proprio la nuova corsa alle armi di un paese che, nelle volontà americane, dovrà in questi anni ricoprire un ruolo strategicamente rilevante nell'area dati i due “scomodi vicini”.
Non c'è (mercato)nero senza bianco. Le armi del mercato nero provengono per lo più dai vecchi arsenali di Saddam – quelli in cui avrebbero dovuto esserci le mai trovate armi chimiche e batteriologiche casus belli della seconda guerra del Golfo – rivendute spesso da ex militari del regime ba'athista o da cittadini comuni che hanno trovato nel mercato illegale delle armi un modo come un altro per pagarsi pane (un dollaro per 500 g), sigarette (un pacchetto di Marlboro costa 1.72 dollari) e bollette (in media 120 dollari per un appartamento di 85 metri quadrati)
Secondo l'Iraqi Weapons Act – il documento stilato durante il periodo di transizione per regolare l'uso di tutti i tipi di armi, anche quelle chimiche e batteriologiche - chi viene sorpreso a trafficare illegalmente armi – sia per il mercato interno che oltre confine – rischia la pena di morte, anche se in Parlamento si sta discutendo di una eventuale riduzione ad ergastolo. Anche perché, per dirla con l'analista militare iracheno Imad Allo, anche il mercato nero in situazioni come quella che sta vivendo attualmente il Paese serve a far girare l'economia.
Perché tutto questo giro di armi in un paese che sta ricostruendo le proprie forze armate? Perché la gente comune non si fida della polizia, utilizzata spesso come strumento di repressione basato più sulla vendetta tribale che non su concetti come “giustizia” e “democrazia”.
Dalla guerra esterna alla guerra civile? Gli americani se ne sono andati definitivamente l'anno scorso, lasciando un paese allo sbando.
Dovevano esportare una democrazia che avrebbe naturalmente migliorato la vita dei cittadini iracheni, i quali, veniva raccontato in Occidente, non ne potevano più di Saddam Hussein e del suo regime. Allo stato attuale delle cose, l'unico potere realmente esportato non è quello del popolo ma quello della guerra, con una recrudescenza dei rapporti tra sciiti e sunniti che sta portando ad una serie sempre più lunga di attentati (80 morti e più di 300 feriti in totale) ad opera dello “Stato Islamico dell'Iraq”, braccio armato di Al Qaeda che opera in «reazione alle uccisioni e torture di prigionieri sunniti incarcerati nelle prigioni sciite».
Neanche il tentato governo “bi-etnico” del premier sciita Nouri al-Maliki – che aveva scelto come vice il sunnita Tariq al-Hashimi – sembra aver disinnescato gli attriti tra i due gruppi, anche alla luce della condanna a morte spiccata contro quest'ultimo, accusato di alcuni attentati avvenuti tra il 2006 ed il 2007. Secondo al-Hashimi, che non riconosce l'autorità del tribunale che lo ha giudicato e da dicembre ha trovato asilo in Turchia, dietro questa accusa ci sarebbero le contestazioni ai modi estremamente autoritari usati da al-Maliki, del quale da più parti (in particolare quelle curde) vengono denunciate pratiche simili a quelle dittatoriali.
In un senso di instabilità simile, ancor più drammatica diventa l'incidenza di quanto avviene lungo il confine con la Siria, dove sono già oltre 35.000 i profughi in fuga dal regime di Bashar al-Assad secondo il governo regionale curdo.
Alcuni testimoni hanno raccontato ad “Osservatorio Iraq” di un Iraq sempre più in prima linea nell'armare i ribelli siriani – con le armi che passerebbero ad Anbar come a Mosul dando una qualche giustificazione ad un così florido mercato nero delle armi pesanti – nonostante la neutralità più volte dichiarata da al-Maliki ed il fatto che il governo sciita sia vicino ad Assad. Se tali voci trovassero conferma, sarebbe interessante capire se e quante di quelle armi provengano dai ricchi contratti di fornitura che l'Iraq sta firmando sia con gli Stati Uniti che con la Russia, diventati in questi ultimi anni i due maggiori fornitori di armamenti del Paese.
Sicurezza personale e lungo i confini. È questo, dunque, il motivo reale per cui l'Iraq ha riavviato la sua corsa agli armamenti. Anche perché – dicono i sostenitori di questa tesi – gli americani hanno lasciato completamente indifeso il paese e si sa, alla neutralità è sempre bene accompagnare un po' di deterrenza.
La “comunità internazionale” (se ancora ne esiste una dopo le ultime guerre umanitarie) dovrebbe porre l'attenzione su come tutto questo traffico d'armi potrebbe essere giustificabile non soltanto con il principio di “autodifesa” ma anche – o soprattutto? – nella supremazia sciita. L'ultima volta che un gruppo etnico è stato lasciato alla sottomissione di un altro gruppo etnico all'interno di uno stesso stato nazionale – hutu e tutsi in Rwanda – sappiamo come è andata a finire.
La guerra fredda dei contratti. L'unica, concreta, neutralità fino ad ora realizzata dal governo iracheno è proprio nel campo degli armamenti, dove i contratti si firmano sia con gli Stati Uniti che con la Russia, rinsaldando in quest'ultimo caso un vecchio legame dell'epoca ba'athista con una compravendita prevista di 5 miliardi di dollari, utile anche nell'ottica economica e geopolitica della ricostruzione del ruolo iracheno nell'area.
15 miliardi, per ora, stanziati per carri armati M1A1 e caccia F16 Block52 in aggiunta ai droni che andranno a sorvegliare i pozzi petroliferi strategici per USA ed Europa - in caso Teheran dia seguito concreto alla più volte minacciata chiusura dei rubinetti - provenienti dall'industria bellica statunitense che rendono la direttrice Washington-Baghdad la principale via per il commercio legale di armi con l'Iraq, seguita dalla via che conduce dritta dritta nelle stanze del Cremlino (per il quale l'Iraq rappresenta il secondo mercato dopo quello indiano) che ha riaperto ufficialmente il canale diplomatico con l'Iraq dopo 4 anni, ospitando poco più di un mese fa il premier al-Maliki in un meeting durato tre giorni. Con l'industria bellica del Presidente Medvedev sono stati firmati contratti per 30 elicotteri da combattimento Mi-28NE, 42 piattaforme mobili per il lancio di missili Pantsir-S1, caccia MiG29M/M2, aerei Sukhoi, armi medie e leggere, autocarri blindati e pezzi di ricambio. In più – stando ad un'intervista di Hakim al-Zamili ad AlMonitor – il ministero della Difesa sta pensando di acquistare sempre dai russi piattaforme di missili terra-aria e sistemi radar da installare in funzione anti-turca nella regione del Kurdistan iracheno, quando il governo regionale acconsentirà.
#OccupyBassora. La società civile irachena – che non vuole vivere in un “WeaponState” non sta certo a guardare.
Mentre a Washington i “signori della guerra” si spartivano i contratti del settore bellico-privato, a Bassora oltre 150 persone si riappropriavano delle strade, contrapponendo al “meeting della guerra” americano il “meeting della pace”. Oltre 5000 persone hanno infatti alle due maratone d'apertura della tre giorni del Secondo Forum della Nonviolenza nel quale sono stati affrontati, tra gli altri, i problemi dei lavoratori come il “daily work” (mediante il quale una giornata di lavoro costa 10 dollari) dell'ecosistema mesopotamico – dove un mega-progetto turco vorrebbe fermare il corso del Tigri lungo il confine attraverso la costruzione di 220 dighe, contro le quali è partita la campagna“Save the Tigris and Iraqi Marshes” - e dell'impunità verso i reati commessi dai contractors, che stanno diventando per l'Iraq ciò che i narcotrafficanti rappresentano per il Messico. Proprio per frenare l'eccessiva libertà di cui godono queste agenzie, dalle associazioni della società civile era arrivata la richiesta di una convenzione che ne regolasse in sede sovranazionale l'attività. Come era prevedibile, questa è stata però fortemente osteggiata da quei paesi che il sistema della “guerra privata per procura” l'hanno inventata. Stati Uniti e Gran Bretagna in testa.
A luglio, inoltre, si era tentata in sede ONU la via dell'istituzione di un Trattato che regolasse il commercio internazionale di armi. I veti – concreti o “virtuali” - incrociati di Stati Uniti, Russia e Cina hanno reso vano qualunque discorso in merito.
Le armi sono la continuazione della (geo)politica con altri mezzi. Ma qual è, nei fatti, il ruolo che l'Iraq di al-Maliki si sta ritagliando? Ufficialmente vicino al regime siriano e secondo alcuni analisti sempre più influenzato dal regime degli ayatollah iraniani, il premier racconta il suo paese avviato ad una sempre maggiore autonomia, in particolare da Washington, di cui pilastro portante è il petrolio che potrebbe delineare per l'Iraq uno scenario simile a quello che è stato e continua ad essere il Venezuela di Chávez. In più il governo avrebbe evidenziato un certo fastidio per i ritardi nella fornitura bellica americana (nella quale Obama sembra stia via via disimpegnandosi), dando conferma alle lamentele di un altro (ex?) alleato americano come Hamid Karzai, che ha minacciato di rivolgersi proprio ai russi in caso di ulteriori ritardi americani.
Russia che starebbe interessandosi anche ad investimenti nel settore petrolifero iracheno e che potrebbe rappresentare quello che Cuba rappresenta per il Venezuela nel settore latinoamericano in un'area dove l'asse Mosca-Teheran è ormai un dato di fatto.
[1 - Continua]
(foto: un bambino "gioca" con una pistola di plastica. Le armi sono diventate parte della cultura e della quotidianità nell'Iraq "liberato" fonte:Niqash.org)
Andrea Intonti [http://senorbabylon.blogspot.it/]