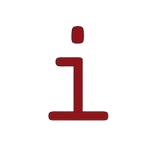InfoOggi Cinema
Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah, l'autore Antonio Pettierre: "una vita al massimo"
Il libro Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah di Antonio Pettierre, edizioni Arcoiris, compie questo mese un anno dalla pubblicazione. L'abbiamo ripreso dagli scaffali delle librerie, ancora rivestito del suo smalto di analisi e più attuale che mai, per intavolare una discussione con l'autore sul cinema di Sam Peckinpah, concedendoci più di una fuga in avanti in direzione del cinema contemporaneo.
Come emerge nel saggio di Antonio Pettierre, Sam Peckinpah, tra gli anni Sessanta e Settanta, è stato autore fondamentale prima nell'accelerare la ristrutturazione interna del western, già crepuscolare, che il regista californiano ha interpretato rovesciando i canoni della narrazione, aprendo a una ridda di anti-eroi dalla presenza fisica e dalle complesse sfumature psicologiche, nonché rivoluzionandone l'estetica tra slow-motion e montaggio sincopato; poi, partendo dal western stesso, nel contribuire a decodificare "il passaggio dal periodo classico al moderno (e postmoderno) della New Hollywood" (p. 15), il rinnovamento del cinema americano consumatosi con autori come Arthur Penn, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Robert Altman e altri pezzi da novanta. Il saggio di Pettierre racconta in maniera snella l'intreccio tra vita e cinema, con densità d'informazioni, il passo scandito dall'analisi in ordine cronologico dei film e la qualità precipua dei buoni saggi cinematografici: farti venire una maledetta voglia di vedere tutti i film del regista. Che un po' maledetto, a proposito, lo fu - tra contrasti perenni con le produzioni e dipendenze varie, tali da compromettere parte della sua produzione finale, ma non da portare a disconoscerne il ruolo di visionario pioniere di un cinema nuovo. Antonio Pettierre ci racconta.
ANTONIO MAIORINO: non ti farò una domanda sul titolo del libro, Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah, perché hai spiegato bene le sfaccettature del concetto di frontiera, che dal senso geografico - tra Messico e Stati Uniti - passa anche a significato più prodondo di luogo “in cui nascondersi per vivere i giorni di gloria finali”. Concedimi che probabilmente ci sarebbe stato bene anche un qualsivoglia titolo che giocasse con quello di uno dei suoi capolavori, Il mucchio selvaggio. L’idea del mucchio, infatti, è – oserei dire – strutturale nel cinema di Peckinpah, al di là del noto film del 1969. In che senso?
ANTONIO PETTIERRE: l'idea di mucchio coincide con quella di gruppo, di banda. In tutti i film, al di là di quelli del selvaggio west, si ripete l’amicizia di personaggi virili che costituiscono un gruppo chiuso in cui ci si sostiene a vicenda. Si ripete anche nei film non western, di altro genere. Il concetto di mucchio, peraltro, non si rinviene solamente all’interno del gruppo protagonista che porta avanti la storia, ma si allarga ad altri tipi di gruppi. Facciamo degli esempi. Proprio nel film Il mucchio selvaggio, ci sono anche i cacciatori di taglie che danno la caccia alla banda di Pike Bishop e che per certi versi sono anche più selvaggi rispetto ai banditi. C’è poi il mucchio dei soldati, perché c’è la sequenza dell’attacco a un treno dell’esercito statunitense, e anch’esso è un gruppo caotico. Anche nella parte iniziale del film c’è un’associazione di donne e uomini contro l’alcolismo e la prostituzione. Ma potrei fare esempi tratti da altri film: in Convoy – Trincea d’asfalto, del 1978, c’è un altro tipo di mucchio, quello dei camionisti.

A.M: ecco, forse il gruppo dei camionisti in Convoy è a suo modo esemplare per spiegare l’associazione mucchio\caos che troviamo spesso nel cinema di Peckinpah: i bisonti della strada si oppongono all’uomo di legge, lo sceriffo interpretato da Ernest Borgnine, come cowboy moderni che rispondono solo alle regole del proprio mucchio, a un’etica interna alla propria comunità. Ma lo sceriffo, come lo definisci nel tuo libro, è cattivissimo: la legge della città è inumana, è anch'essa una forma di violenza.
A.P: la città e la comunità, diversamente dal cinema classico, sono contesti in cui nasce il caos: sono selvagge, appunto, non sono comunità di ordine. C’è quindi in qualche modo un disordine che deriva dal mucchio in generale. Facciamo un altro esempio sempre mantenendoci ai film. In Cane di paglia, Dustin Hoffman si trasforma da professore di matematica a difensore della legge contro la comunità diventata gruppo selvaggio che attacca la sua casa per stanare Henry Niles (David Warner). L’uomo, affetto da ritardo mentale, ha infatti ucciso involontariamente una ragazza del villaggio e rischia il linciaggio da parte della comunità. Il concetto di mucchio, quindi, non è solo fisico ma anche ideologico: non si scontrano singole individualità, ma individui e diversi gruppi o bande. Usando un termine americano: posse. La posse che si scontra può essere anche la stessa cittadina, lo stesso villaggio, perché da lì nasce il caos.
A.M: viene allora da dire che proprio in combinazione con questa idea di mucchio, emerge nel cinema di Peckinpah anche il rilievo eccezionale dell’individuo. Scrivi nel tuo libro: “i protagonisti (...) sono sempre fuorilegge che combattono contro tutto e tutti, personaggi liminari per carattere, anarchici, ribelli..” (p. 16).
A.P: nel cinema di Peckinpah ciò che conta è rappresentato appunto dall’individuo, la sua forza, la sua libertà che lo fa uscire dalla comunità proprio perché essa genera il caos. Un altro esempio è quello dei bambini: non sono innocenti. Pensiamo sempre all’incipit del film Il mucchio selvaggio, con dei bambini che stanno mettendo uno scorpione all’interno di un covo di formiche e poi gli danno fuoco. Viene fatto capire che la violenza nasce dall’infanzia. Anche in Cane di paglia ci sono i bambini che giocano, e sembra quasi un idillio, ma poi ci si accorge che stanno giocando in un cimitero. Ciò che emerge è un senso mortifero, di male che è innato alla comunità umana.
A.M: c’è però anche un concetto “estetico” di frontiera. Sia all’inizio che alla fine del tuo libro, sottolinei che Peckinpah cambiò il modo di girare il western, ma che poi quelle innovazioni fecero da ponte per gli autori della New Hollywood ed ebbero la forza di essere travasate in altri generi al di là della frontiera del western; penso a film come Getaway o Killer Elite. In che modo avvenne?
A.P: quando Peckinpah fa western, il genere è ormai alla fine del suo viaggio e lui comincia d’altro canto a girare altri tipi di film, soprattutto film d'azione. Se pensiamo a Getaway del 1972, ad esempio, è uno dei film che decripta quello che sarà tutto il genere del thriller e dell’action movie degli anni Ottanta e Novanta. Troviamo in generi diversi dal western alcune degli elementi di stile che hanno reso celebre Peckinpah: il montaggio sincopato, la commistione di sequenze con più movimenti di macchina, la presenza di sequenze più elegiache in contrasto a quelle violente. Altro esempio: uno dei suoi film più importanti e belli è La croce di ferro, unico film di guerra che ha girato. Ebbene, ciò che si nota è come ripeta i meccanismi del cinema western all’interno del cinema bellico.
A.M: scrivendo proprio del film La croce di ferro, hai descritto lo scontro tra il sergente e il capitano che vediamo nel film come "una metafora tra il regista e il sistema degli studios hollywoodiani” (p. 126). A cosa si dovevano quei rapporti difficili con la produzione? Al carattere notoriamente difficile, o alla singolarità della sua visione artistica, poco compatibile coi meccanismi dell'industria hollywoodiana?
A.P: entrambe. Studiando la sua biografia e le sue testimonianze, comprese quelle degli amici, ti confermo che aveva un caratteraccio: lo dicevano tutti, era molto spigoloso e autoritario. Era il tipo che se non gli stavi simpatico, diventava aggressivo. La seconda ragione è tipicamente artistica. Fin dalle produzioni televisive ha sempre ribadito di aver voluto il controllo totale. È un autore a tutto tondo. Orson Welles rimproverava i propri collaboratori tecnici chiedendogli perché facessero certe cose, e quando loro ribattevano, "ma io ho pensato che…", lui tagliava corto dicendo: "tu non devi pensare: è il regista che pensa". Stessa cosa per Peckinpah. Ma puoi ben capire, in un mondo in cui gli executives hanno l’ultima parola, lo scontro è inevitabile con questo tipo di personalità umana. Ci sono diverse testimonianze da parte di produttori per cui Peckinpah veniva considerato intrattabile e ingestibile. Nella produzione americana questa è una macchia; per intenderci, lo è stato anche per Michael Cimino. Peckinpah non accettava compromessi; anche gli amici riferivano che faceva sfuriate ma chi gli stava vicino riconosceva anche che era un genio ed era generoso verso chi lo seguiva. Poi ha avuto ovviamente nella seconda parte della sua carriera una grande influenza il fatto che vivesse la vita a velocità massima. In qualche intervista ha dichiarato: "sono un alcolista che fa film". Cominciò anche a drogarsi. Alcuni film nel finale della carriera, come Convoy, li ha dovuti interrompere: in quel caso, ad esempio, film l’ha portato a termine l’attore che dirigeva la seconda unità, James Coburn. Peckinpah si chiudeva nella roulotte e non dirigeva più. Era completamente anarchico, era selvaggio. Non ho voluto usare questo termine perché già in tante monografie era chiamato così: Bloody Sam, Sam il selvaggio, ecc. La frontiera del titolo era anche umana, spostava tutto al limite di quello che poteva chiedere a se stesso, sempre più avanti fino a pagarne le conseguenze. Ha avuto una vita intensissima come una candela che brucia da entrambe i lati ed è morto relativamente giovane.

A.M: dietro la continuità stilistica tra western e altri generi in Peckinpah, compreso Convoy, c’è anche la continuità di collaborazione con la sua crew, ossia con un gruppo fidato di collaboratori?
A.P: Peckinpah è innanzitutto un grandissimo direttore di attori. Riusciva a tirare fuori grandi interpretazioni anche dai pessimi attori. In più, come direbbero i francesi, era un grande metteur en scène: gestiva il set in modo molto controllato. Aveva lavorato molto sia con lo slow motion che col montaggio sincopato, tipico proprio de Il mucchio selvaggio nelle sequenze finali ma che si ritrova anche in altri film di genere thriller o bellico; il problema è che poche volte riusciva a ottenere il final cut, perché a volte la produzione subentrava nel montaggio e lo estrometteva, ottenendo l’ultima parola sul film. Persino per Il mucchio selvaggio, il suo film più rappresentativo, da diverse interviste apprendiamo che per Peckinpah il film è suo solo al novanta per cento, a causa del mancato controllo totale sul montaggio. Ciò non toglie che nel suo modo di lavorare amasse circondarsi della propria crew, anzi, aveva un rapporto viscerale con alcuni attori così come con la troupe tecnica. Due nomi su tutti: Jerry Fielding per la colonna sonora e Lucien Ballard per la fotografia. Per il fatto di essersi voluto circondare della propria “famiglia” cinematografica, della propria banda, possiamo dire che facesse film molto intimisti, personali, e che il genere diventasse piuttosto un’occasione per iterare un certo tipo di stile, proponendo alcune figure virili o femminili. In altre parole, il genere è una confezione con cui fare il suo cinema, che sia western, bellico o spionistico come in Killer Elite e Osterman Weekend.
A.M: a proposito di Osterman Weekend: trattandosi di un film ambientato nel mondo della televisione, di genere spionistico, hai indicato qualche assonanza con Videodrome di David Cronenberg, precisando le differenze.
A.P: sono due autori completamente diversi, parto da questo presupposto: ne ho estremizzato la comparazione: Osterman Weekend è quasi una metafora della vita di Sam Peckinpah, che si era formato come autore televisivo, e mi è sembrato che il film fosse quasi un finale di trasmissione per il il fatto che l’ultima inquadratura sia quella di uno studio vuoto. Peckinpah parla dello smascheramento del potere e della costruzione della falsità di ciò che si vede, in cui la televisione gioca un ruolo decisivo perché può modificare la realtà. Videodrome di Cronenberg è un film completamente diverso, soprattutto nelle finalità e per il suo tono filosofico: è basato sulle mutazioni sociali comportate dal villaggio globale, con dietro le teorie di Marshall MacLuhan. Osterman Weekend è quasi la nemesi della vita di Peckinpah: il protagonista (John Hurt), agente della CIA, architetta una trappola per uccidere l'antagonista (Burt Lancaster) costruendo qualcosa che non esiste attraverso la televisione. L'ultima immagine è quella, come dicevo, di uno studio televisivo vuoto, e poco dopo Sam Peckinpah muore. Sembra quasi che il film diventi un testamento, come se sapesse di dover morire. A posteriori l’ho trovato molto significativo e molto bello, una bellissima uscita di scena.
A.M: hai parlato della formazione di Peckinpah come autore televisivo. In che modo due aspetti poco noti di Sam Peckinpah, quali le esperienze giovanili nel teatro e appunto nella televisione, da te ben ricostruite nella prima parte del libro, sono state decisive per lo sviluppo della sua carriera e della sua visione artistica?
A.P: sono state la sua scuola, il suo laboratorio. Al di là di quello che si è detto su Peckinpah, anche a livello di gossip, lui era un uomo estremamente intelligente, con una grande cultura. Per anni era stato direttore di un teatro in California; uno dei suoi autori preferiti era Tennessee Williams, che qualcuno potrebbe pensare totalmente distante da Peckinpah e che invece gli interessava molto. Infatti le psicologie dei suoi personaggi hanno un’influenza letteraria più che puramente cinematografica. Quanto alla televisione, è stata l’ambiente in cui è maturato. Tieni conto che in quegli anni, a differenza di adesso in cui c’è osmosi tra cinema e televisione, chi intraprendeva la carriera televisiva restava spesso in quel settore. Anche per Peckinpah c’è stato un momento in cui passava dal cinema alla televisione in base al successo o insuccesso dei propri film. Le sue esperienze e il suo modo di girare, che poi ha portato innanzitutto nel western, li aveva già sperimentati nella televisione. È lì che ha incontrato anche i suoi primi direttori della fotografia e attori che l’avrebbero seguito nel nel cinema. Brian Keith, attore della serie The Westerner girata per la tv da Peckinpah, ha fatto debuttare lo stesso regista nel film La morte cavalca a Rio Bravo. Il produttore aveva presentato questo film a Brian Keith e lui ha chiesto di avere Peckinpah come regista. Già si sapeva che Peckinpah fosse di difficile gestione, ma l’attore lo riteneva un genio e lo pretese per quel film.
A.M: si sapeva che era ingestibile perché anche nelle opere televisive non erano mancati contrasti con la produzione.
A.P: all’epoca, i western televisivi andavano nella fascia serale ed erano ben visti. La maggioranza delle serie tv erano western perché andavano per la maggiore nella prime time americana. The Westerner è una serie capolavoro di Peckinpah, ma durò solo una stagione per scontri col produttore. Era sperimentale perché non era il classico western: c’era violenza cruda, le storie non avevano sempre un lieto fine, eppure erano dirette perfettamente. Le riprese di alcuni episodi erano pienamente cinematografiche, inusuali per la tv dell’epoca. Il produttore voleva invece normalizzare per il formato televisivo; Peckinpah non accettò e la serie fu chiusa dopo una stagione. Molti autori della New Hollywood si sarebbero formati all’università, ma al tempo di Peckinpah non esistevano ancora in campo cinematografico e la vera scuola era la tv, che consentiva a molti autori di fare il salto per fare il cinema, oppure gli Studios stessi che facevano la scuola. Solo negli anni Settanta cambierà il modo di formarsi degli autori.

A.M: alla fine degli anni Sessanta, Peckinpah aveva presentato al produttore esecutivo della Warner Bros, Kenneth Hyman, due sceneggiature: quella de Il mucchio selvaggio insieme a quella de La ballata di Cable Hogue. Il primo fu un successo e consentì al regista una relativa libertà nel girare il secondo, che definisci “il primo film fortemente e completamente voluto da lui”. Ma La ballata di Calbe Hogue fu un flop: tutti si aspettavano una violenza quasi da exploitation, mentre il film aveva toni a tratti elegiaci, persino ironici, da commedia western. Ti sentiresti di dire che il successo de Il mucchio selvaggio stava diventando una sorta di arma a doppio taglio?
A.P: hai detto bene. Dopo Il mucchio selvaggio, che ha avuto grande successo di pubblico, i produttori si aspettavano sempre la ripetizione dello stesso film, mentre Peckinpah voleva fare altre cose. La ballata di Cable Hogue è quasi l’altra faccia del modo di fare il cinema di Peckinpah, fa quasi coppia con Il mucchio selvaggio. Il suo è un cinema elegiaco, ma anche Il mucchio selvaggio lo è, perché non c’è azione fine a sé stessa e continuativa, bensì intervallata da momenti di calma, come la quiete prima della tempesta. Anche per Pat Garrett e Billy the Kid, film massacrato al punto di essere ancora oggetto di studi filologici per la diversità della versioni che circolano, il produttore voleva una ripetizione de Il mucchio selvaggio, tanto è vero che la prima versione tagliata si risolse in una serie di sparatorie e fu un clamoroso flop perché non si capiva niente. Volevano un film violento, che non era nelle intenzioni di Peckinpah. Ne La ballata di Cable Hogue la parte elegiaca viene estremizzata. Peckinpah lo definisce il più personale perché è uno dei pochi film in cui ha avuto totale controllo. Più che non aver avuto successo, direi che non è stato praticamente distribuito; mia supposizione è proprio che i produttori si aspettassero un altro tipo di film e non ritenevano che avrebbero avuto gli incassi desiderati. Anche ne L’ultimo buscadero con Steve McQueen c’è questo aspetto elegiaco: la violenza è solo implicita, il film è un’elegia. Questo passaggio della carriera di Peckinpah è cruciale ed è quello che gli ha fatto cambiare genere. Se ne andò in Inghilterra per girare Cane di paglia e abbandonò il western.
A.M: parlando di Cane di paglia del 1971, altro grandissimo film anche se – a quanto racconti – accettato da Peckinpah con un certo distacco, ti soffermi sulla scena di stupro di Amy (Susan George), moglie del protagonista interpretato da uno strepitoso Dustin Hoffman. In chiusura, ti lanci in un paragone affascinante: la violenza carnale in Arancia meccanica di Kubrick. Qual è la differenza tra i due registi nell’approcciare la violenza?
A.P: Cane di paglia e Arancia meccanica sono dello stesso anno, quindi è nel clima di quel periodo che si avverte questo senso di violenza. La differenza è che quella di Kubrick è una violenza fredda, intellettuale, quasi sarcastica, distaccata; quella di Peckinpah è carnale, ravvicinata. Rivedendo il film di Kubrick, non ti fa lo stesso effetto di Cane di paglia, la cui sequenza resta ancora oggi molto cruda: lo spettatore è all’interno della scena di violenza. Quella di Kubrick, pur appartenendo a un film capolavoro, risulta quasi un esperimento intellettuale. Ho fatto questo confronto nel libro perché entrambe sono scene di violenza carnale, ma uno – Kubrick – sembra allestire un balletto, mentre l’altro – Peckinpah – rappresenta la realtà. Sia chiaro: Peckinpah non lo fa per esaltare la violenza, bensì per mostrare a cosa essa possa portare e per allontanarsi da essa. La violenza nei suoi film ha sempre una sporcizia di fondo, deve far parte di una rappresentazione realistica che, creando repulsione, funzioni quasi come una medicina o un antidoto, laddove per altri la violenza è piuttosto un’occasione estetica.

A.M: sarà solo a pagina 116 del tuo libro che verrà fuori un nome a cui, probabilmente, tanti lettori cinefili avranno pensato, parlando di violenza nel cinema: quello di Quentin Tarantino. Anzi, prendi due piccioni con una fava: nello stesso paragrafo parli anche dell’influenza di Peckinpah su Oliver Stone. Restiamo sul tema: come cambia la rappresentazione della violenza in questi tre registi?
A.P: Peckinpah ha influenzato sia Tarantino che Stone, che riprendono quel tipo di rappresentazione ma in modo diverso. Tarantino, si sa, è un autore di pastiche, ha grande cultura cinematografica, si è formato in una videoteca vedendo migliaia di film. La sua rappresentazione della violenza, in Pulp fiction ma anche nei suoi western The Hateful Eight e Django Unchained, sono postmoderni, quasi fumettistici. Tarantino costruisce e decostruisce con una visione personale, quasi astratta, creando qualcosa di nuovo. Oliver Stone fa un’operazione ancora diversa: in Natural Born Killers, Stone compie un’operazione postmoderna in cui combina cinema, immagini televisive, realistiche, multimediali, entro vari registri sia semiotici che stilistici, dunque un’operazione a tavolino. Tarantino e Stone partono dalla violenza di Peckinpah e vanno oltre, ma senza Peckinpah non ci sarebbe stato probabilmente tanto cinema successivo di cui sia Tarantino che Stone sono tra gli esempi più celebri. Un altro esempio: Walter Hill (autore di cult come I guerrieri della notte e Strade di fuoco, n.d.R.) è stato sceneggiatore di Getaway. Il suo cinema riprende i modi di Peckinpah e senza Peckinpah non avrebbe fatto quel tipo di film.
A.M: del film Voglio la testa di Garcia, altro vertice del cinema di Peckinpah, parli come di un pastiche di generi. Ne sono colpito, perchè proprio di recente ha messo quasi tutti d’accordo un film-pastiche, cioè Parasite di Bong Joon-ho, vincitore a Cannes e agli Oscar, inafferrabile nella sua continua variazione di tono. Vuol forse dire che Voglio la testa di Garcia contiene un aspetto fortemente in linea col cinema contemporaneo?
A.P: hai perfettamente ragione. Il pastiche è un elemento classico del cinema postmoderno. Il postmoderno ormai è in realtà post-post-post-moderno, è un concetto storicizzato. Nel 2020 non si può più parlare di postmoderno, aveva senso farlo 20-30 anni fa. Parasite è un film pienamente contemporaneo che fa i conti con questa storicizzazione, per cui il suo senso post-moderno è in qualche modo innato: la contaminazione alto-basso, tematiche massimali e minimali, mescolanza di stili e generi. Questo è il cinema contemporaneo, e questo fa Bong Joon-ho, ma all’epoca di Peckinpah non era scontato: un cinema di questo tipo era frutto di una costruzione. Voglio la testa di garcia è un’operazione veramente eclatante da questo punto di vista perché nella stessa opera passiamo attraversi diversi registri: inizia come un western, poi diventa un revenge movie ante litteram, poi ancora una storia d’amore, peraltro bellissima, tra un loser, questo pianista americano sconfitto, e una prostituta; il tutto, in un Messico che non esiste più, perché Peckinpah ha fatto riprese in una parte del Messico che nessuno più ha portato nel proprio mondo cinematografico. E ancora, il film diventa un thriller; dopo la famosa sequenza del cimitero, addirittura è quasi un film horror, perché c’è un punto in cui non sappiamo se il protagonista è veramente morto, sta sognando o è una proiezione di quello che può succedere. Infine, c’è una conclusione (spoiler, n.d.R.) anch’essa clamorosa: il famoso fermo-immagine sulla bocca di una pistola col rumore delle pallottole esplose dagli spari. Quanto di avanguardistico aveva il film, all’epoca non fu compreso né dalla critica né dal pubblico. A raccontarlo così nel 2020, si direbbe è un film magnifico. A distanza di decenni è infatti attualissimo, sembra di vedere un film fatto da un regista contemporaneo.
A.M: nel libro riesci davvero a ricreare visivamente alcune scene del film. Quali altre trovate pensi siano potenti in Voglio la testa di Garcia?
A.P: quello di Warren Oates è un personaggio grandissimo. Ma c’è tanto altro di moderno: c’è persino, anche se non esplicitamente, una coppia di killer che potrebbero essere omosessuali, quindi la tematica viene fatta intuire; poi c’è una famiglia messicana armata che cerca di recuperare la testa di Garcia, loro congiunto; e soprattutto, questo convitato di pietra, il personaggio della testa che diventa un MacGuffin perché non si vede mai durante tutto il film: si vede solo un sacco, e anche questa è un’altra idea incredibile. Personalmente, il più grande capolavoro di Peckinpah al livello de Il mucchio selvaggio è questo. È un film che rivedendolo anche adesso è entusiasmante perché in ogni scena e in ogni battuta ti commuove, ti colpisce, ti stupisce, in continuazione, fino alla fine.
A.M: tu pensa che lo vidi a 18 anni, insieme a degli amici di liceo, poiché l’aveva citato en passant il nostro Professore di Storia e Filosofia. Come ragazzini, rimanemmo piuttosto perplessi; nel corso degli anni, come allora, ho continuato a trovare spiazzante la dilatazione della parte della storia d’amore, la parte elegiaca. Il titolo generava altre attese. Ma la tua analisi fa capire perfettamente l’organicità di quella sezione del film rispetto alle successive esplosioni di violenza.
A.P: per vedere Voglio la testa di Garcia, serve già una diversa maturità spettatoriale. Ti dirò, il primo film che ho visto di Peckinpah, dal canto mio, è stato Il mucchio selvaggio a 16 anni, e fu uno shock. Lo vidi per puro caso in televisione e mi colpirono soprattutto le sparatorie. Non conoscevo bene Peckinpah, tranne che per Sierra Charriba (del 1965, n.d.R), film però massacrato dai produttori in fase di montaggio. La sequenza iniziale de Il mucchio selvaggio mi colpì profondamente. Voglio la testa di Garcia, come dicevi, può essere spiazzante. La sequenza della storia d’amore con la prostituta è anomala, ma pensa appunto quanto sia importante il fatto che includa un momento di violenza carnale, e come sia perfetta per la scena successiva che si svolge al cimitero. Si capisce che è un film violento in cui ogni incontro con altri personaggi finisce con uno scontro e l’unico momento di pace è proprio in quella storia d’amore con la prostituta.
A.M: per questa gestione delle parti di quiete e quelle di dramma violento, possiamo dire che anche Voglio la testa di Garcia è un film manifesto di Peckinpah.
A.P: Peckinpah diceva che La ballata di Cable Hogue era il suo film più personale, ma io penso che sia questo il film più personale del regista. Basti pensare al fatto che Warren Oates, l’attore protagonista, si era trasformato fisicamente in Peckinpah: lo si capisce dalle fotografie, e dalla versione originale captiamo anche che la voce originale imitava quella dello stesso Peckinpah. Voglio la testa di Garcia è dunque quasi un film autobiografico della sua spiritualità, del suo modo di essere: è Peckinpah col suo modo di vivere e di vedere la realtà. È il film che più lo rappresenta dal punto di vista umano.

A.M: vengo all’ultimissima fase della produzione di Sam Peckinpah. Riporti una testimonianza di Katy Haber, per cui il regista avesse accettato con poco entusiasmo film come Convoy – Trincea d’asfalto e Killer Elite, precisamente con lo spirito “di una buona puttana che va dove lo mandano”. Per di più, anche se a inizio intervista mi dicevi di un Peckinpah grande metteur en scene, nell’analisi che fai di film come Killer Elite (1975) e Osterman Weekend (1983) osservi proprio problemi di messa in scena, come nella sequenza finale del porto di San Francesco di Killer Elite. Eppure, i temi sembrano ancora rivelare lucidità: dopo aver chiuso i conti con la frontiera del western nella scena finale di Pat Garrett e Billy the Kid, sembra che Peckinpah fosse comunque un fine osservatore del suo tempo. In che direzione stava andando, prima di morire a 59 anni, questo regista infiacchito a livello tecnico ma forse ancora vivo nello sguardo?
A.P: Peckinpah aveva una visione molto cinema della realtà e già capiva come si stesse spostando la frontiera: da Occidente a Oriente, così come verso la comunicazione mediatica. In altre parole, la frontiera stava diventando la globalizzazione. Era indebolito, però, e non aveva più la forza per realizzare delle opere pienamente riuscite, anche a causa delle sue condizioni di salute. Gli mancava persino la forza di combattere coi produttori, che quindi prendevano i film completamente in mano. Un caso esemplare è proprio in Osterman Weekend: nella versione di Peckinpah, il presentatore televisivo interpretato da Rutger Hauer è un cinico doppiogiochista, mentre in quella attuale, frutto del montaggio della produzione, sembra quasi diventare l’eroe positivo, tutto d’un pezzo. Certo, a Peckinpah non mancavano le intuizioni perché era geniale, la lucidità era ancora viva in effetti; ma il suo cinema era, per statuto, fortemente fisico, e come tale lo viveva, per cui gli riusciva molto difficile girare. In una delle ultime interviste rilasciate al regista francese Olivier Assayas, all’epoca redattore per i Cahiers du Cinema, vediamo fisicamente che Peckinpah è stanco, malato, indebolito.
A.M: e questo non poteva che riverberarsi sul suo cinema.
A.P: per forza: viveva sul set, si sentiva realizzato solo quando girava un film. è uno di quegli autori della storia del cinema la cui vita è simbiotica rispetto al cinema. A differenza di tanti altri registi, non puoi scindere il suo cinema dalla sua vita. L’uomo e l’artista coincidevano, erano lo stesso soggetto pensante e operante. Per capire il cinema di Peckinpah bisogna capire l’uomo e viceversa.
SCHEDA LIBRO

Autore: Antonio Pettierre
Editore: Arcoiris
Collana: Nastri d'argento
Anno edizione: 2019
In commercio dal: 30 ottobre 2019
Pagine: 152 p.
EAN: 9788899877354
(immagini: in copertina, dettaglio dell'artwork del poster de Il mucchio selvaggio; all'interno, prima: fotogramma da Il mucchio selvaggio, seconda: fotogramma da La croce di ferro; terza: foto d'epoca di Sam Peckinpah; quarta: fotogramma da Cane di paglia; quinta: fotogramma da Voglio la testa di Garcia; in basso: copertina del libro Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah. Si ringrazia l'editore Arcoiris)