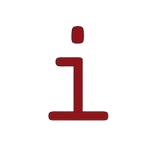Dieci anni di cinema americano sono tanti da raccontare. Se poi si tratta del decennio appena trascorso, il viaggio critico diventa ancora più avventuroso. In Fabbrica di sogni, deposito di incubi. Dieci anni di cinema USA. 2010-2019, per Mimesis Edizioni, Stefano Santoli si lancia in una ricognizione appassionante ed equilibrata di temi e tendenze del cinema statunitense degli anni dieci. Una società in evoluzione, quella americana; e il cinema che recepisce, trasformandosi a sua volta. C'è l'incubo dell'11 settembre appena messo alle spalle, ma anche il sogno americano che pare un mito un po' sbiadito, un cartolina del '900. Mentre premono nuove istanze - su tutte, quelle gender e afroamericane - il cinema muta nelle tecniche (il 3D, il pianosequenza) e nelle strategie (il tempo del racconto), sperimenta nei generi (animazione, horror, western, sci-fi), fa sentire la voce di autori nuovi (Chazelle, Saulnier, Zahler) e vecchi (Scorsese, Lynch, Malick e gli altri). Ne abbiamo discusso con Stefano Santoli.
L'INTERVISTA: STEFANO SANTOLI RACCONTA FABBRICA DI SOGNI, DEPOSITO DI INCUBI
ANTONIO MAIORINO: qualche tempo fa, il Prof. Uva, curatore insieme al Prof. Zagarrio del libro Le storie del cinema. Dalle origini al digitale (Carocci Editore), mi disse in un'intervista: “il lasso di tempo necessario per la storicizzazione degli eventi si è sempre più assottigliato e questo ce lo insegnano gli stessi storici”, aggiungendo, però, che per quanto riguardava gli anni recenti del cinema, la sua opera poteva limitarsi solo a una fotografia. Sei d'accordo sulla questione della storicizzazione? Come ti sei avvicinato a un decennio di cinema così prossimo da non poter essere facilmente inquadrato nell'immediato?
STEFANO SANTOLI: sono d’accordo. Obiettivamente nelle varie discipline si è ridotto il margine di storicizzazione, ma certo non abbastanza da poter storicizzare quanto successo praticamente ieri. Nell’introduzione ho scritto di non aver voluto effettuare un tentativo di storicizzazione. Ciò che invece ho fatto, entro la struttura dei quattro capitoli portanti, è stato creare una mia sistematizzazione, pur senza voli pindarici o filosofie personali. Ho fatto una fotografia anche io, senza avvertire il peso del problema della storicizzazione. Avevo in mente un testo come quello di Roy Menarini e Leonardo Gandini (Hollywood 2000. Panorama del cinema americano contemporaneo. Generi e temi – Autori, Recco, 2001, n.d.R.), una curatela sull’allora recente cinema statunitense degli anni ’90 che arrivava al cambio di secolo. Ancora, quello dello stesso Menarini sul cinema degli anni zero (Il cinema dopo il cinema. Dieci idee sul cinema americano 2001-2010, Genova; n.d.R.). Come in questi lavori, mi sono collocato in quella zona liminare tra storia e critica.
A.M: dal tempo allo spazio: il territorio del cinema americano, anche recente, è tutt’altro che incognito. Hai percepito, tuttavia, che il tuo libro recasse un elemento di novità proprio per la sua volontà di mettere in ordine l’ultimo decennio del cinema statunitense?
S.S: quando ho cominciato a pensare a questo libro in concreto e a scriverlo, mi sono spesso chiesto se sarei stato il primo a propormi presso una casa editrice. Come dicevi, saremo forse in decine ad aver avuto la possibilità di vedere quasi tutto del decennio americano e di essere pertanto nelle condizioni di poter svilupparne un’analisi. Pensavo di avventurarmi su di un terreno in cui tanti avrebbero potuto dire la loro. D’altro canto, non parliamo di cinema armeno! Ho però voluto farlo a modo mio: avevo idee personali che intendevo sistematizzare.
A.M: è anche vero il contrario: rispetto ai decenni precedenti, mancava una bibliografia ampia. Quanto è stato prezioso, allora, poter confrontare le tue idee con quelle della critica delle riviste e in particolare di quelle online, che tendono sempre più a diventare nuove forme di archiviazione?
S.S: la mole bibliografica era contenuta rispetto ad altri decenni, quindi, a dispetto delle comunque corpose letture che ho avuto modo di fare, mi sono potuto muovere con relativa libertà. In sintesi, analisi di singole opere che si trovano nel mio libro sono rintracciabili nella critica online o cartacea, ma ancora non sono presenti in un vasto numero di volumi.
A.M: l’ultimo film che citi nel prologo del tuo libro è The Walk (2015) di Robert Zemeckis, che rievoca l’impresa di Philippe Petit, il funambolo capace di passare dall’una all’altra delle Torri Gemelle camminando su un cavo d’acciaio sospeso a 400 metri da terra. “Le Torri sono crollate, l’America è in pericolo, il futuro è incerto”, scrivi, alludendo al cinema come rigenerazione del mito. È questo precario equilibrio del colosso americano, e allo stesso tempo questo suo sogno della seconda opportunità, il vero filo conduttore di Fabbrica di sogni, deposito di incubi?
S.S: il filo conduttore lo suggerisce proprio il titolo. Il cinema statunitense propone una mitologia popolare con finali catartici ed eroi positivi che trionfano, ma proprio questo rivela inconsciamente la paura della fine. Il tema portante del volume, dunque, non è di natura stilistica, nonostante il forte sbilanciamento su aspetti di stile e produzione nel primo capitolo. Come si evince meglio dal secondo capitolo, Sguardi al passato, e dal terzo, Sguardi al presente, il filo conduttore è proprio quello del sogno e dell’incubo. Lo si potrebbe applicare a qualsiasi decennio del cinema americano a partire dagli anni ’40, ma in ogni decennio secondo le proprie peculiarità. In quello appena passato, in particolare, ho voluto rilevare l’allontanamento dall’incubo dell’11 settembre ma allo stesso tempo la consapevolezza per gli USA di affrontare un secolo che mette in discussione la propria egemonia. Il ‘900 diventa così un mito, ma allo stesso tempio una gabbia da cui è impossibile uscire, in quanto secolo fatto di glorie che appartengono al passato. Per intenderci, così come il West, a sua volta, proprio per il ‘900.
A.M: a proposito: hai dedicato al western un paragrafo apposito nel secondo capitolo, con relativi titoli – da Tarantino, ai Coen, fino a Kelly Reichardt – che mostrano la vitalità, oserei dire, “attualizzata” del genere. Se il nuovo mito è quello del ‘900. come fa a sopravvivere il western?
S.S: siamo abituati a considerare un film western quando si svolge nel Midwest, nell’800, in grandi spazi liberi e all’aperto. Ci sono però anche approcci che considerano western alcuni film ambientati in scenari contemporanei. Io non l’ho fatto, ad esempio, con The Counselor (2014, Ridley Scott), ma è sicuramente un western un film come I segreti di Wind River (2017) di Taylor Sheridan, a sua volta sceneggiatore di Hell or High Water (2016, David Mackenzie). Cosa rimane di western a un film se togli l’ambientazione storica? Io credo il concetto di frontiera e la dialettica tra individuo, radici e orizzonti da trascendere. È questo che consente al western di affermarsi al di là della storia ed eventualmente travasarsi in altri generi.
A.M: ho divagato in direzione del secondo capitolo, Sguardi al passato, per collegarmi alla tua osservazione sul western, ma ora vorrei fare un passo indietro. Nel primo capitolo, Finzione e immersività, racconti il particolare uso del pianosequenza in 1917 di Sam Mendes. Il pianosequenza dovrebbe puntare a realismo e immersività, ma visuali e movimenti della mdp sono platealmente innaturali, così come la gestione del tempo. E concludi, a proposito delle “attuali attitudini di fruizione cinematografica”, “che è impossibile prevedere se e per quanto resteranno attuali, o invece verranno superate (...)”. Chi sono, secondo te, gli influencer cinematografici che rendono attuali o superate certe scelte filmiche? È un moto che parte dal basso, ossia dagli interessi del pubblico, oppure arriva dall’alto, con azioni di rottura degli autori?
S.S: entrambe le cose. Propendere per l’una o per l’altra in misura maggiore o minore significherebbe sottovalutare l’altro aspetto. Per me un film come 1917 è il frutto di un incontro tra il gusto e la necessità del pubblico di essere immerso nell’opera filmica, da un lato, e la sfida profondamente personale di un regista, così come di un direttore della fotografia, dall’altro. C’è una componente di virtuosismo, di accettazione della sfida ereditata dal recente impiego del pianosequenza nel mainstream, come in Iñárritu e Cuarón. Per farlo, bisogna avere esperienza e mezzi notevoli, ma allo stesso tempo contava sapersi inserire in una certa congiuntura di gusto e attese. Questo vale anche in casi diversi di cinema d’autore internazionale. Faccio l’esempio di Lav Diaz. È un caso estremo di predominanza del lato autoriale, il pubblico quasi non esiste. Ma quale? Quello di massa. Eppure un pubblico esiste, eccome: Lav Diaz non avrebbe cominciato a fare quei film se non avesse avuto interlocutori privilegiati, minoritari ed elitari nel circuito dei festival. Difficile trovare l’autore che non abbia presente un certo tipo di pubblico, tanto più per la presenza di una produzione che investe.
A.M: in tema di produzioni, hai dedicato parte consistente del primo capitolo alla questione del 3D. A leggerne, sembra per larghi tratti la storia di un’innovazione collettiva, frutto di imprese produttive, piuttosto che oggetto di percorsi autoriali. In che misura, secondo te, il 3D si può prestare ad essere analizzato non già come novità dell’industria nel suo complesso, bensì come elemento espressivo di singoli autori?
Il 3D ha un percorso carsico nella storia del cinema, affiorato anche in decenni molto lontani, per esempio negli anni ’50, e nulla esclude che possa dar luogo a un uso consapevole e autoriale. Forse è ingenuo da parte mia pensarlo, ma trovo delle analogie nella storia dell’impiego del colore. Gli autori che hanno usato il colore, almeno in Europa, lo hanno provato in maniera barocca: Fellini in Giulietta degli Spiriti, Antonioni in Deserto rosso, Bergman in Sussurri e grida. Dove il colore veniva adottato, se ne cercava l’esplicita impronta. Col 3D in America ci troviamo in un contesto produttivo diverso, ma c’è il caso interessante di Ang Lee. È vero che con Vita di Pi si è servito del 3D per lo spettacolo, secondo l’uso che ne imponeva il momento, ma poi, più di Iñárritu, Cuarón o Cameron, ha saputo fare dei film come Billy Linn o Gemini Man in cui il 3D non è molto visibile. Sono esperimenti isolati, in cui il 3D è molto innestato nel tessuto del film. Ecco, penso possa accadere qualcosa del genere: se il 3D avesse un’esplosione, si innesterebbe in modo così naturale che non ce ne si accorgerebbe più, proprio come oggi non ti soffermi sul fatto che un film sia a colori.
A.M: altri casi meritevoli di citazione per quanto riguarda il 3D? Ang Lee è un isolato?
S.S: ricorderei almeno Wim Wenders in Europa e Martin Scorsese in America. Per quest’ultimo bisogna ovviamente sottolineare che il film in questione, Hugo Cabret, implicava l’uso autoriale del 3D per creare un ponte con il cinema delle origini di Méliès. Tuttavia, dopo averci messo il proprio timbro d’autore, Scorsese ha smesso di utilizzarlo.
A.M: Hugo Cabret è un esempio di cinema attento alla citazione. Proprio la citazione è una delle caratteristiche del postmoderno, fenomeno al cui superamento dedichi un discorso molto circostanziato, contrapponendogli una più marcata tendenza verso il reale da parte del cinema del decennio. Hai scritto: “nel cinema degli anni Dieci predomina una violenza verace più autentica e concreta, e gli stessi stilemi postmoderni mostrano il fiato corto” (p. 103). Rispetto al loro rapporto col reale, il postmoderno e il cosiddetto cinema del reale possono essere considerati come due termini opposti? Se sì, quali film indicheresti per l’uno e per l’altro, per renderne immediatamente chiara la differenza?
S.S: il concetto è naturalmente più sfumato, ma mi piace questo gioco e ti rispondo volentieri. Tra l’altro il cinema del reale è proprio l’estremo del capitolo Sguardi sul presente, allorché cito autori come Chloé Zao, Andrea Arnold e Roberto Minervini. È un’etichetta che si applica bene, ma va presa con le molle e contestualizzata più nel cinema italiano che in quello statunitense. Al punto che l’autore principale è proprio Minervini, più di Zao e Arnold. E allora, come estremi ti dico: per il postmoderno, The Neon Demon (2016, Nicolas Winding Refn); per il cinema del reale, Stop the Pounding Heart (2013, Roberto Minervini). Sono film diversissimi e lontani, che sembrano provenire da continenti diversi, eppure appartengono allo stesso decennio.
A.M: hai usato un aggettivo, prima, che ricorre più di una volta in Fabbrica di sogni, deposito di incubi: carsico. Lo usi quando parli dell’affiorare di certi temi che in profondità già esistevano. Il capitolo Sguardi sul presente è impressionante da questo punto di vista: sembra che per ognuna delle tante sfaccettature sociali della società statunitense degli anni dieci – tra cui, giovani adulti, afroamericani, parità di genere – ci sia stata una reazione immediata del cinema, in gradodi generare subito un nucleo di film. Tale reattività è caratteristica del decennio, oppure c’è sempre stata, ma solo appare più evidente, in quanto i temi sociali sono anche social, ossia, apertamente dibattuti sui social media?
S.S: mi azzardo a dire che questo decennio, rispetto a quello precedente, è diventato improvvisamente un decennio reattivo, persino troppo. Si percepisce l’urgenza di trattare determinati temi. Non ho potuto includere alcuni titoli recentissimi nel mio libro, ma in merito al me too si può pensare a Promising Young Woman (2020, Emerald Fennell) oppure alla fioritura del cinema afroamericano. I temi vengono come cavalcati, innescando un dibattito che porta al successo del film. Ciò si lega al fatto che viviamo in un’immediatezza data dal web 2.0 e dai social che portano a stare subito a ridosso dei temi. Ma non è sempre stato così. I mutamenti generazionali degli anni sessanta non si sono manifestati in presa diretta, c’è stato un lasso di tempo da quando avvenivano a quando il cinema li metabolizzava. Il contesto produttivo degli anni sessanta si è avvalso del successo di Easy Rider (1969, Dennis Hopper) per svecchiare il panorama cinematografico e introdurre, all’inizio dei settanta, temi che erano stati centrali nel decennio precedente.
A.M: è esistito nello scorso decennio un tipo di cinema americano che meglio si è prestato come laboratorio di elaborazione di questi temi sociali?
S.S: ci sono film che trattano tematiche tangenti al me too o al black lives matter, i cui temi sono espliciti sin dalla locandina: lo capisci prima ancora di vederli. Tuttavia, ci sono anche film di genere, soprattutto horror, che affrontano in maniera meno immediata alcune questioni. A parte Jordan Peele, che ne ha fatto un tratto peculiare, mi sono molto divertito a ragionare su pellicole che trattano tematiche attuali e problematiche sociali contemporanee in tempo reale, senza però farne una bandiera di comunicazione. Ci tengo a dirlo, perché in un periodo di traumi sono spesso il cinema di genere e in particolare l’horror a rielaborarli facilmente. È avvenuto nell’horror degli anni quaranta, ma anche negli anni del Vietnam, sempre con horror che non vi alludono in maniera diretta, ma elaborano comunque il tema in anticipo rispetto al cinema di guerra che verrà dopo.
A.M: torno al libro Le storie del cinema di Uva e Zagarrio che citavo nella prima domanda e che hai incluso nella tua bibliografia. Il Prof. Zagarrio mi disse nell'intervista: "oggi si racconta la storia del cinema per prodotti, generi, tipologie e metodologie, piuttosto che per fenomeni autoriali rispetto a registi intesi come artisti”. Cionondimeno, in Fabbrica di sogni, deposito di incubi ti muovi costantemente alla ricerca di caratteristiche per le quali un regista possa o meno dirsi un autore. La cosiddetta "politica degli autori" è ancora affidabile in sede di analisi filmica, o le storie del cinema, ormai, si raccontano per fenomeni generali?
S.S: io vengo dalla critica, per quanto mi sia sempre appassionato per mia deformazione a sistematizzare le idee. Per mia tendenza personale, sono un autodidatta come studioso di cinema. Sono europeo, provengo da una passione adolescenziale per gli autori, poi sviluppata negli anni a venire. Amo Bergman, Tarkovskij, Kieslowski, Antonioni; in America, Kubrick sopra ogni altro. È una mia attitudine: cerco di riconoscere la cifra autoriale da quando mastico cinema. Non so se faccio bene o male. Sono consapevole del fatto che questo aspetto non sempre emerge nel cinema americano. In alcuni casi vorrebbe affiorare, come in Scott Cooper (Crazy Heart, Out of the Furnace, Hostiles; n.d.R.), ma non vi riesce. In altri casi, non c’è affatto autorialità: lo dico esplicitamente di autori come Kenneth Branagh o Bill Condon, "mestieranti" che si prestano facilmente a fare cinema su committenza. Il caso di Scorsese è diverso. È americano ed è un grande autore anche se non si scrive i film da solo; l’autorialità gli viene dalla scelta del soggetto e dal linguaggio più squisitamente cinematografico. È la dimostrazione che il cinema non è solo sceneggiatura, ma è soprattutto - forse - regia.
A.M: Scorsese appartiene a quella vecchia guardia di registi ancora impegnati in una ricerca autoriale, a cui dedichi il capitolo Percorsi d’autore: Malick, Lynch, Allen, Eastwood, Tarantino, Anderson. Sottolinei, invece, la mancanza di giovani, a tuo dire, segno “della sfiducia delle case di produzione verso gli autori” (p. 184). Ci sono eccezioni tra le nuove leve?
S.S: Damien Chazelle (Whiplash, La la land, n.d.R.) è un giovane autore. Ha delle ossessioni ricorrenti. Le riconoscerebbe anche un cieco! Altri nomi riconosciuti come autori in maniera univoca sono i fratelli Safdie, mentre più azzardata da parte mia è l’identificazione di Craig Zahler e Jeremy Saulnier. Lì mi sono permesso di sbilanciarmi. Non è facile per i giovani emersi in questo millennio far vedere di avere una loro poetica. Chazelle è un caso isolato ed ha avuto molto successo. Fa film ogni tre anni. Le difficoltà produttive rendono difficile la vita di chi abbia ambizioni autoriali: se fai film ogni tre anni e ti viene male un film, diventa tutto più complicato. Non ho fatto una statistica, ma in generale gli autori che conosciamo e hanno una carriera di più decenni producono con intensità e frequenza da giovani, dopodiché tendono a rallentare.
A.M: in chiusura: Fabbrica di sogni, deposito di incubi è uscito poco prima di Cannes 2021. Ti sorprenderesti se vincitori di Cannes, o anche di Venezia, come già successo, nel prossimo decennio dovessero risultare anche vincitori degli Oscar?
S.S: non ho la sfera di cristallo! (ride, n.d.R.) Ma va precisato che il discorso di Cannes è diverso da quello di Venezia. Cannes ha degli autori consacrati che accedono al concorso solo se già riconosciuti. Ha un rapporto stretto col cinema americano, dagli anni ’70 almeno, ma non guarda tanto alla competizione degli Oscar. Diverso il discorso di Venezia, in cui l’attuale gestione ha un occhio di riguardo per l’Academy, per ciò che arriva alla notte degli Oscar. Seleziona determinati film; li presenta in opportune posizioni; chiama a presiedere la giuria certi registi che hanno già vinto il festival; premia film americani che arrivano poi a vincere a febbraio a Los Angeles. Si tratta di una politica ben precisa, ed è un dato di fatto che porti lustro a Venezia, ma gli precluda di essere un festival, come Berlino o Locarno, proteso alla ricerca di cinematografie e autori nuovi e periferici.
A.M: non hai la sfera di cristallo, ma a cosa farai particolarmente attenzione nei prossimi anni? Quali fili del discorso sono rimasti in sospeso?
S.S: quello che più m’interessa in prospettiva statunitense è verificare se continuerà ad esserci una globalizzazione sempre maggiore del cinema americano, con l’afflusso di cineasti da ogni parte del globo che vanno a lavorare in America. In particolare, sarei curioso di capirlo per quanto riguarda il rapporto con la Cina.
L'AUTORE
Stefano Santoli è saggista e critico cinematografico. Collabora con “Cineforum”, “Il Ponte” e con la rivista online “Ondacinema”. Si occupa di cinema statunitense, cinema giapponese e del rapporto fra documentario e fiction. È autore di saggi dedicati a Joshua Oppenheimer, Rithy Panh, Wim Wenders, Werner Herzog e Makoto Shinkai. Ha pubblicato Lo schermo e il taccuino (2013). Laureato in Scienze politiche e dottore di ricerca in Diritto costituzionale, è valutatore per ANVUR.
SCHEDA LIBRO
EDITORE Mimesis
AUTORE Stefano Santoli
PREFAZIONE Leonardo Gandini
PAGINE 248
PREZZO 20 euro
COLLANA Cinema
USCITA 24 giugno 2021
ISBN 9788857578859
(immagini: principale, dettaglio della copertina di Fabbrica di sogni, deposito di incubi; all'interno: fotogrammi di film citati nell'intervista e nel libro, nell'ordine: The Walk, 1917, Billy Lynn, Get Out; ultima immagine: copertina del libro)