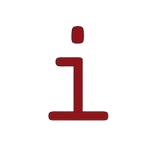Estero
Dadaab, la città dei profughi
DADAAB, (KENYA) - 450.000 persone su un territorio di circa cinquanta chilometri quadrati, con un incremento di oltre mille persone al giorno che si stanziano su quel fazzoletto di terra che è circa la metà della città di Firenze. Sarebbe, per estensione, la terza città più popolosa del Kenya. Se solo fosse una città.[MORE]
Siamo a Dadaab, un'ottantina di chilometri dal confine con la Somalia, nella zona nord-ovest della Repubblica kenyana, in quello che è considerato il campo profughi più grande del mondo. Aperto nel 1998, dati grandezza e popolazione è stato suddiviso in tre campi più piccoli – Hagadera, Ifo e Dagahaley – ai quali si stanno via via aggiungendo altri campi, come Ifo II, da quando è stato dichiarato inadeguato ad accogliere nuove persone. Cosa che succedeva tre anni fa.
Tre ospedali, quindici ambulatori e una ventina di scuole. Questo offre la “città dei rifugiati” a chi scappa da una guerra – quella somala – mai realmente placatasi dal 1991. Nonostante l'ampio dispiegamento di forze “umanitarie”, però, la crisi nel campo non è affatto risolta. Basti considerare che solo la metà dei bambini riesce ad accedere all'istruzione primaria e un terzo a quella secondaria, anche per i tentativi di esclusione verso i nuovi arrivati, ai quali viene imputato di abbassare il livello di istruzione di cui è possibile usufruire.
I rifugiati sono costretti a rimanere all'interno dei campi, nei quali sono identificati solo attraverso un braccialetto giallo e un pass di identificazione. Questo però comporta che coloro che risiedono da più tempo all'interno dei campi siano completamente dipendenti dagli aiuti umanitari distribuiti dalle tantissime organizzazioni non governative presenti a Dadaab. Capire se siano loro ad aver bisogno degli aiuti o, al contrario, le ong a “campare” sui rifugiati diventa impresa assai ardua.
L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), che gestisce il campo insieme ad alcune organizzazioni non governative come Oxfam e Medici senza frontiere, ha definito in 43,7 milioni le persone che scappano dai propri paesi per il clima – cambiamenti climatici e, nello specifico, la peggiore siccità registrata nel Corno d'Africa negli ultimi sessant'anni - le guerre o la fame. A questi vanno poi aggiunti altri 27,5 milioni di sfollati che rimangono però all'interno dei propri paesi d'origine.
A questo punto – data anche la vicinanza con il periodo festivo – potremmo mettere la questione in termini “umanitaristi” e sfruttare il senso di colpa che viene a noi occidentali (o quanto meno dovrebbe venire) quando vediamo le immagini dei bambini che subiscono l'essere nati nel continente povero del mondo dalle brochure o dagli spot da trenta secondi che passano in televisione ma che servono – parzialmente – solo per lenire in parte la colpa di essere nati nel “ricco e democratico” Occidente. Sono ormai decenni che queste campagne vengono fatte, che schiere di organizzazioni non governative ci invitano a donare, ad adottare a distanza e tutte queste belle cose che, però, non migliorano di un millimetro la situazione generale. Perché non saranno certo le offerte o le adozioni a distanza a far terminare i conflitti nel continente, tanto meno a far deporre le armi agli eserciti – regolari o “di liberazione”, la differenza è impercettibile – che caratterizzano la storia africana. La vecchia storia del riso e della pesca di confuciana memoria, forse, ha insegnato meno di quel che potrebbe apparire.
Credo, invece, che sia più interessante – di quanto sta alla volontà del lettore, naturalmente – andare a capire come si è arrivati al campo profughi di Dadaab ed agli altri campi presenti nel mondo o al bambino sulla brochure. Credo, cioè, che per eliminare un problema (la fame, la guerra, la criminalità) sia necessario estirparne le radici marce piuttosto che i rami secchi. Che sono solitamente quelli più facili da raggiungere.
Nelle scorse settimane abbiamo visto come sullo sviluppo del continente africano incidano “forze terze” attraverso l'acquisto delle terre (fenomeno del “land grabbing”) o dei debiti di natura finanziaria (mediante l'uso dei cosiddetti “vulture funds”). Oggi continuiamo a parlare di speculazione, argomento quanto mai di moda nella cara vecchia Europa, ma lo facciamo da un punto che viene troppo spesso ignorato dai media e dalla politica ma con il quale tutti, dai “poveri” contadini africani ai “ricchi” cittadini occidentali, dobbiamo fare i conti tutti i giorni.
La speculazione alimentare. Secondo la Fao e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (meglio nota come Ocse), da qui al 2020 i prezzi dei cereali e della carne aumenteranno fino a toccare picchi del venti o trenta per cento in più rispetto ad oggi. I media ci informano da tempo, insieme alla classe politica, che la colpa sia da attribuire in larga parte al livello di sviluppo raggiunto dai paesi in via di sviluppo. Ma è davvero così? È davvero il diritto delle popolazioni di questi paesi ad una dieta decente – quantitativamente e qualitativamente – a causare l'impennata dei prezzi della carne o dei cereali oppure ci sono altri motivi? Insomma: chi guadagna con il cibo?
Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro. L'anno è il 2008, l'anno cioè in cui gli americani iniziavano a perdere le loro abitazioni per la crisi dei mutui subprime che ha poi generato la crisi con la quale stiamo facendo i conti in questi mesi. Ma il 2008 è stato anche l'anno del miliardo e venti milioni di nuovi affamati denunciati dalla Fao e dovuti all'impennata dei prezzi del mais, del frumento e del riso – considerate le tre materie prime agricole più importanti – sui mercati internazionali. Raggiunto il picco massimo, le quotazioni tornarono ben presto a livelli accettabili, come ogni bolla speculativa che si rispetti vuole. Da giugno 2010 i prezzi del grano e del mais hanno cominciato una nuova corsa verso l'alto, raddoppiando nel primo semestre del 2011, nonostante la produzione alimentare è aumentata sia nel 2008 che nei primi mesi dell'anno che sta per chiudersi. Logica economica vorrebbe, dunque, che con l'aumentare della quantità di bene a disposizione sul mercato il prezzo vada a diminuire.
Per capire, allora, i motivi di queste impennate bisogna evidentemente guardare da un'altra parte. Quale parte sarà al centro della seconda parte di questo articolo.
(1 - Continua.)
Andrea Intonti